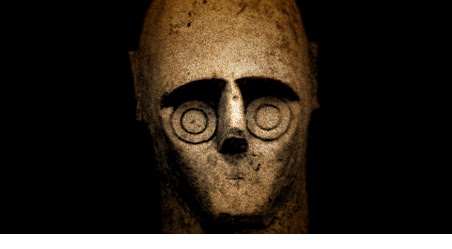la Terra dei mucchi di Pietre, cap XXIV
di Maurizio Feo
24. Gli ultimi eroi.
Nei giorni che seguirono, Lauchme accolse gli ultimi
messaggi sui più recenti avvenimenti.
I messaggeri da Orwa erano trionfanti. E ciò
traspariva già da come stavano ritti in groppa ai loro cavalli - leggeri nella
ritrovata libertà, esultanti i loro modi e le parole, dimenticato ogni buio orrore della guerra, laggiù
si stava costruendo un radioso futuro. Nella terra bruna e profonda sembrava rifondata l’antica Larissa,
fertilissima per i mille rivoli gonfi di acqua feconda che la bagnavano.
L’operosità e l’armonia vi regnavano sovrane, tanto che l’avrebbero chiamata
Olbìa, “Città Felice”.
Meno raggianti erano invece quelli di Karul e di Kares, le due città del Golfo
Grande. Anch’essi parlavano per la verità di vittoria, anch’essi riferivano di
mare sgombro e pulito - ma qualcosa offuscava il fulgore degli occhi ed un
turbamento indugiava sui loro volti.


Dopo il sopravvento della flotta in aiuto da Kur -
fu il loro resoconto - i Cartaginesi della seconda flotta si videro privati di
ogni residua via di fuga e selvaggiamente si erano riversati avanti,
ciecamente, aprendo con rabbia una profonda ferita lungo i campi che erano
stati gialli di crisantemi nella bella stagione e che adesso nereggiavano tristemente
per il sangue versato, per la furiosa distruzione del fuoco, per un ultimo
passaggio disperato dell’inutile umana follia. Un giorno intero si poteva
viaggiare ormai per quei luoghi profanati e specchiarsi in essi come nello
specchio buio e tetro della morte.
Hanys era giunto con i suoi, armati del nuovo
mortale segreto metallo Isarno, forgiato nella nuova città guardiana, ed aveva
tenuto fede al suo nome iroso e ribelle - Vento Divino di Tempesta - tagliando
gli scudi e gli elmi, facilmente spezzando le spade nemiche, urlando il nome di
Ennin e fermando il loro insano oltraggio alla terra.
“I messaggeri di Kar parlano di vittoria” -
interruppe il loro racconto Lauchme - “ma ne parlano con toni che si addicono
di più ad una sconfitta: qualcosa che ancora non hanno detto é successo, a
sciupare il pieno trionfo. Che cosa?”.
Ma il sacerdote temeva la risposta, perché da molti
segni segreti già conosceva i semi del tempo futuro, da cui ineluttabile
sarebbe germogliato il destino della sua gente.
Il tempo degli dei era da
lungo tempo perduto e da molti dimenticato. Il tempo degli eroi volgeva ormai
alla fine.
Lauchme già sapeva nel cuore che gli ultimi eroi
erano caduti.
E i messaggeri subito piansero e si strapparono i
capelli e - confermando quei nomi - molti altri ve ne aggiunsero, fra noti ed
ignoti, di tutto valore. Libero era il mare. Spesso in tempesta, adesso che il
vento freddo ne tornava unico ed incontrastato padrone. Con il freddo si addormentava
il figlio-sposo della Grande Madre e questa lo riaccoglieva nel suo grembo fino
al prossimo caldo. Per giorni e giorni le navi Shardana si erano spinte con
grande pericolo oltre il possibile, senza vedere alcun segno. Il pericolo era
trascorso, dissolto in quelle volubili onde meravigliosamente blu, increspate di un capriccioso bianco in cima, che avrebbero proibito da adesso per almeno
cinque lune ogni presenza umana.
Dalle sponde di Karul, in quella stessa acqua era
stata spinta - secondo l’accorato resoconto dei messaggeri - la snella nave di
Mandras, con a bordo le sue spoglie e le sue armi. Toccò proprio a Iolao, il
suo più fedele luogotenente, dar controvoglia fuoco alla pira, sussurrandogli
l’ultimo rispettoso e segreto saluto. E mentre la nave si consumava nel suo
ultimo e breve viaggio, da tutto il Golfo si udivano mille voci unite insieme
nel coro antico per la morte dell’eroe:
“Il Re si é disteso e non si alzerà più,
il signore di Kullab non sorgerà più;
avuto successo sul male, non tornerà più;
benché così forte di braccio non sorgerà più.
Saggezza aveva ed un viso aggraziato, ma non verrà più.
Se n’é andato sulla montagna, non tornerà più,
giace sul letto del fato, non sorgerà più,
Iolao si era poi fatto un sacro dovere di raccontare
come Mandras il Grande avesse combattuto quell’ultimo giorno. Una sola canzone
non sarebbe bastata.
Magon il cartaginese e suo fratello Hasdrubaal - capi della flotta e dell’esercito - erano stati affrontati,
schiacciati e vinti da Mandras uno dopo l’altro, col furore infernale che egli
sapeva scatenare improvviso sul nemico sgomento. Questo aveva privato i
Cartaginesi del comando e aveva così affrettato la loro totale disfatta. Ma
aveva anche offerto un bersaglio obbligato alla loro rabbia, ormai cieca: molti
altri erano caduti sotto i colpi vendicatori di Mandras, ma le frecce e le
lance ormai cercavano lui e soltanto lui. Ed infine - purtroppo - lo avevano
trovato e fermato per sempre. Hanys coraggioso gli era corso incontro,
tagliando le folte schiere nemiche come i molli favi dell’alveare, recidendo le
fibre intrecciate degli scudi e le vene pulsanti dei corpi, sprizzandone fuori
il sangue come se fosse miele.
E in realtà, sembrava davvero che egli già
pregustasse dolcemente la propria morte. Così li avevano trovati, più tardi,
spenta ogni resistenza in quel luogo: caduti vicini uno di fronte all’altro, ancora
una volta alla pari, amici e rivali imbattuti, le mani protese a cercarsi per
darsi aiuto. Deposte le armi inutili per dare e ricevere un ultimo conforto,
interrotti nel loro estremo, fatale confronto. Gli ultimi eroi.


La voce profonda di Iolao già sembrava intonare una
canzone funebre in lode del’amico ucciso: “Giorno infausto e terribile! Ora é
completa la misura e tutti gli altari grondano del caldo sangue delle vittime
oltre i canali colmi, oltre ogni famelica intenzione divina di vendetta. Mi interrogo
sul volto sbiadito dell’amico, del fratello, dell’eroe. Mi domando se non avrei
mille volte preferito servire un avido padrone straniero insieme a lui,
piuttosto che gustare in solitudine il miele amaro della riconquistata libertà”.
A questo resoconto Lauchme proruppe, alzando la
mano destra in preghiera: “Oh, acre sapore della vittoria, quando perdono
colore i volti familiari e non più speri di udire il riso delle voci amiche.
Ora é veramente colma la misura. Interamente pagato il prezzo nel sangue.
Io
vi dico che fra tredici lune ricorderemo questo giorno e saremo tristi. Attorno
a nuovi fuochi accesi canteremo in memoria dei nostri eroi, immoleremo le
vittime in ringraziamento e ne trarremo auspici.
E così ogni nuovo anno, per
sempre. Tornate alle vostre genti con il messaggio di un importante nuovo raduno - qui, presso il tempio di Tal-Ur - da tenersi alla
prossima luna piena, ciò che darà tempo a tutti di compiere il viaggio e di
consumare le feste per la vittoria. Voglio qui le dodici città. Invito qui i
sacerdoti, i capi militari, i giudici, tutti. Desidero parlare insieme, dei
destini delle nostre genti e delle loro. Spero che questo stia tanto a cuore a
loro, quanto a voi e a me. Andate, ora, e siate convincenti. Vi ringrazio per
il vostro valore. Di fronte al sorriso di Ennin”.
____
Hiram - dal suo rifugio segreto ad Othoca - dette
rapidamente tutte le ultime testarde disposizioni, prima di partire: i suoi dovevano
mescolarsi alla folla dei pelliti e degli shardana e fare commenti negativi,
dissuadere dal combattere, demotivare, sminuire il pericolo di Qart-Hadasht...
Doveva spargersi ovunque un sentimento di sazietà
per quanto ottenuto, di invincibilità. Si doveva diffondere il disgusto e
l’orrore per la guerra, in difesa dei nuovi nati che avevano fame. Ci si doveva
domandare quale fosse il vantaggio di portare la guerra a Qart-Hadasht per poi
tornare nelle proprie case abbandonate o distrutte, nei propri campi incolti, a
morire di fame... Questo era il loro dovere: che ognuno poi trovasse da sé i
modi e le parole più convincenti.
Hiram era molto dimagrito, quasi irriconoscibile. Il
volto era coperto da una folta e lunga barba, gli occhi incavati avevano un
aspetto febbricitante e sofferente. Vi si leggeva ancora la tremenda prova di
orrore cui era stato sottoposto, con la perdita della sua piccola, adorata Frine.
Il suo ranocchietto non c’era più. Gli era stato
rubato per sempre su quella terra ostile, nel piatto acquitrino presso Nabui,
in una notte buia e fredda e traditrice... Hiram avrebbe sofferto meno se gli
avessero tagliato un braccio. Ah, gli avessero tolto gli occhi con un trave
acceso!
Adesso, più nulla aveva senso per lui.
Tutto, intorno, gli dava fastidio. Il sole sorgeva e
scaldava, le stelle brillavano candide, i fiori profumavano ancora, struggentemente
belli. Ed il canto degli uccelli rallegrava tutti gli animi, ma non più il suo.
Ogni cosa esisteva ancora, anche
dopo la morte di Frine, anche senza averne più il diritto. Perché Hiram si era
illuso che tutto, ogni cosa, vivesse davvero soltanto per lei, per Frine. Ed
ormai si sentiva tradito, derubato e disilluso, disperatamente solo, per sempre.
Conservava ancora negli occhi l’immagine del suo
passerotto che spirava incredulo, trafitto da una velenosa freccia shardana,
senza un gemito. Vedeva ancora il suo sguardo, fisso nel nulla, farsi
improvvisamente opaco. Dietro di essi, dentro di essi, non c’era più la vita.
Udiva ancora ed ancora nelle orecchie il colpo sordo, subito dopo il sibilo
ronzante... L’orrore e la rabbia gli maceravano la mente ed il cuore: tutto,
dentro di lui era ormai marcio e senza più salvezza. Non aveva più alcuna
voglia di vita, ma il suo animo dolorante non era vuoto: traboccava di un odio
potente. Odiava quella terra nemica con tutto sé stesso. Ed era proprio l’odio a
tenerlo ancora in piedi, malgrado la terribile stanchezza che gli fiaccava il
fisico. L’odio ed il desiderio di infliggere al nemico lo stesso spasmodico
dolore che anch’egli provava in quel momento...
Cercando febbrilmente dentro di sé, trovava immutata
l’antica fedeltà alla città di Elisha. A questo scoglio si aggrappava per non
soccombere, per non essere trascinato via dalle travolgenti ondate di
disperazione che lo scuotevano come un fuscello. Riconosceva i propri doveri ed
i propri ideali, quelli a cui era stato lungamente educato da sempre. Sapeva
che solo la loro realizzazione poteva lenirgli il dolore, distrarlo, rimettere
ordine nella sua mente sconvolta e ridargli almeno una parvenza delle dignità e
serenità perdute.


Esisteva forse una sola persona, sull’isola, che
egli sentiva di non odiare. Si trattava, per quanto strano, di quel sacerdote
pellita, quel Lauchme...
Egli era un suo nemico - forse, anzi, il suo
principale e più pericoloso antagonista - ma gli riconosceva il sacro diritto
di organizzare una difesa della propria terra e della propria gente.
Avrebbe desiderato, se non conoscere, almeno potere
vedere in volto quel sacerdote, perché, in fondo, ne ammirava il coraggio e la
dedizione. Si specchiava in quell’uomo e lo immaginava simile a sé, volontario
schiavo di una medesima ferrea disciplina, devoto ad una divinità egualmente
esigente.
Ma non ce n’era il tempo. Ed inoltre era troppo
pericoloso: ormai il suo volto era troppo noto ai guardiani shardana. Hiram
doveva andare: non c’era più nulla da fare, per lui, sull’isola. Nulla lo
tratteneva più, nulla lo amava: il paradiso si era appassito, per lui.
Hiram si imbarcò segretamente per il tempio di Astarte presso Pyrgi. No, non Astarte: Uni, la chiamavano i Rasenna,
nella loro antichissima lingua.
Doveva allacciare più stretti rapporti con loro.
Pyrgi era il porto della potente Kysra, la più grande città dei
Rasenna. Essi erano più ricchi, grazie al loro fortunatissimo commercio
dell’Isarno e degli altri metalli. Amavano le comodità, le ricche vesti
ricercate, la buona tavola, le raffinatezze e potevano di fatto permettersele
tutte. Erano però bisognosi di alleati forti come i Cartaginesi, perché
sapevano bene di essere circondati da popolazioni ostili ed affamate: gli esuli
Keltoi che si moltiplicavano a nord; i rozzi ed aggressivi Rumach a sud, con la variopinta lega delle città latine di pastori.
E poi c’erano i tracotanti esuli egei, eubei e focei che si affollavano su
tutti i litorali del sud ed avevano flotte potenti e - per Baal! - sapevano navigare
e combattere.
I Rasenna erano ormai distanti dai loro antichi
fratelli della terra del Sole, che erano rimasti rozzi pastori vestiti di
pelli, oppure puzzolenti commercianti di pesce salato. E lui, Hiram, avrebbe
provveduto ad allontanarli ancora di più.


Gli avrebbe fatto conoscere quelle raffinatezze e
quei piaceri orientali che essi non avrebbero poi più voluto abbandonare.
Sarebbero diventati confederati di Qart-Hadasht per
sempre...
Hiram avrebbe presto incontrato il reggente di Kisra
- Thefarie Velianas - e gli avrebbe fatto firmare un trattato solenne di alleanza
militare, commerciale e politica. Il testo del trattato - l’aveva già con sé,
pronto - sarebbe stato inciso su lamine d’oro e di bronzo, in tutte e due le
lingue. Le lamine sarebbero state pubblicamente affisse nel tempio, secondo il
rito sacro, perché tutti i visitatori potessero leggerle.
“Alla Signora, Astarte.
Questo è il luogo sacro che ha fatto e donato
Thefarie Velianas, regnante su Kisra, nel mese del sacrificio al Sole, come
dono al Tempio.
E l’ha doverosamente costruito per beneficio di
Astarte, nel mese di Kerer, nel giorno dell’interramento della divinità e della
semina.
E gli anni della statua della Divinità nel suo
Tempio siano tanto numerosi come queste stelle brillanti”.
Hiram, naturalmente, portava con sè i chiodi d’oro
per affiggere le lamine, così numerosi come un cielo stellato. Sarebbero stati
un dono gradito. Inoltre, portava Gezabel e altre donne esperte nell’arte delle
carezze, da offrire generosamente alla dea del tempio, a sicura riprova della
buona volontà sua e di chi egli rappresentava. E così, tra l’altro, nulla gli
sarebbe più sfuggito di ciò che accadeva su quella parte del mare.
E intanto, Qart-Hadasht poteva con comodo leccarsi
le ferite e prepararsi bene per il suo secondo e decisivo attacco alla terra
del Sole...
Ma questa volta - Hiram giurò solennemente a sé
stesso e a Baal Ammon - non ci sarebbero più stati errori, né mercenari pavidi,
né traditori prezzolati. Hiram si rendeva garante con tutto sé stesso
dell’infallibilità della nuova missione. Si accordò col proprio dio: egli
stesso sarebbe salito sul Tophet e si sarebbe immolato, in ringraziamento finale per
l’ottenuta vittoria. In un solo caso - promise con voce grave - si sarebbe
astenuto dal farlo: se fosse prima morto in battaglia. Ma si augurava che in
quel caso Baal avrebbe gradito egualmente il suo sacrificio...
Questa volta, Qart-Hadasht avrebbe stroncato
brutalmente i suoi nemici: avrebbe portato l’attacco decisivo con la sua forza
migliore, il battaglione sacro di Hiram, per la gloria immortale di Elisha e
dei sacri figli di Tiro...
____
La temperatura si manteneva mite, quasi volesse
aiutare le famiglie i cui uomini durante la guerra non avevano potuto provvedere
alle provviste di legna, (né, se per questo, a tutti gli altri doveri, quali la
caccia ad esempio, o il pascolo). Ma adesso erano tutti animati dal desiderio
di recuperare il tempo perduto.
Per la verità, non proprio tutti coloro che erano tornati dalla guerra. In alcuni
fortunati villaggi remoti addirittura non era giunta alcuna notizia dell’invasione,
né tanto meno della successiva vittoria. Pertanto ai rispettivi abitanti
sembrava molto strana quella gran voglia di festeggiare che gli altri
mostravano.
Alcuni strani gruppi giravano di villaggio in
villaggio, suonando ogni sorta di strumento insieme, flauti d’osso, cetre, trombe,
tamburelli, in bande chiassose e allegre - mostrando gli scudi o altri cimeli,
ad esempio una pelle di leone, o di leopardo (che avevano strappato
personalmente al nemico) e parlavano in modo strano di essere più forti
restando tutti uniti ed altre stramberie.
Ma tant’é - si sa - ovunque l’ospitalità ha i suoi
doveri e comunque si trattava di un’allegra e buona compagnia e raccontavano
belle storie, eccitanti ed interessanti, per cui nessuno rifiutava loro una
buona accoglienza. Alcuni, tra quei variopinti gruppi, avevano forse un ideale,
altri certamente avevano soltanto, furbescamente, risolto il problema del
lavoro e della fatica...
Altri ancora, invece, erano molto più pratici e
sostenevano che si dovevano finalmente riprendere le varie occupazioni, abbandonate
da tanto tempo. Aiutare le vedove ad allevare gli orfani. Basta, pensare alla
guerra!


Fu in questo confuso stato d’animo che - qualche
tempo dopo - il Grande Cerchio tornò ad animarsi per un grande raduno, che
stranamente non sapeva di festa e per il
quale erano intervenuti numerosi personaggi importanti per aspetto, seguito e
ruolo. Molti presero la parola e molte opinioni diverse si infransero
tumultuando le une contro le altre, dopo le prime belle parole d’apertura.
Il Grande Sacerdote espose chiaramente e difese con
forza la propria tesi, che era poi la logica conclusione di quanto aveva
pazientemente costruito fino ad allora.
Il fuoco del nemico non era spento - egli disse -
bensì covava nella cenere la propria bramosia mortificata e sarebbe tornato
molto presto una vampa vorace, forse addirittura alla prossima stagione.
Fu convincente, fu abile e commovente, ma non
vollero credergli, non vollero ascoltarlo.
Invano, Lauchme si adoperò in ogni modo per
spiegare la necessità di dimostrare al nemico che anche le biprore navi Shardana
sapevano attraversare il mare armate. Alcuni lo accusarono inorriditi di volere
spargere altro sangue e piangere altri morti ancora. La carestia e la fame
avrebbero portato con sé le malattie, le pestilenze. Altri si dissero comunque
certi che tutte le navi nemiche fossero state inabissate, con uomini così
numerosi che mai più Cartagine avrebbe osato tanto.
E per che cosa, poi?
Lauchme argomentò ancora che - se necessario - solamente
una luna decorreva dall’abbattimento del
primo albero al varo della nave finita, con l’aplustre intagliato ed ornato
dei colori di guerra. Una nuova e grande flotta poteva quindi essere facilmente
preparata nella stagione fredda. E Cartagine era ricca e potente. Aveva molti
figli levantini - discendenti di Tiro - all’interno delle proprie alte mura e
molti altri ancora - i libici - sparsi nella terra dei leoni e del silfio, di cui non
avrebbe certo lesinato il sacrificio. Sue caratteristiche erano state da
sempre l’inganno e la furbizia, come anche la crudeltà e la cupidigia: i loro
sottomessi avrebbero dovuto inchinarsi fino a terra davanti a loro. Avrebbero
dovuto lavorare incatenati nei campi o remare sulle loro navi e avrebbero perso
le proprie donne, schiave alla loro sensualità, nei loro templi di Ashtart,
disponibili per qualunque viandante o viaggiatore.
Ma ogni buona ragione passa inascoltata, oltre le
orecchie di chi non vuole udire.
Parlarono infine coloro che si dicevano portavoce
dell’equilibrio e del buonsenso, ma che in cuor suo Lauchme riconobbe come i
più egoisti di tutti, perché mascheravano ad arte il proprio interesse e
fingevano di parlare a nome di tutti: pertanto essi erano più colpevoli di
coloro che sinceramente confessavano le proprie paure e manifestavano il
proprio dissenso, senza secondi fini. Gli uomini della Vera Gente - secondo
questi ultimi - dovevano tornare ai loro
lavori, che erano stati troppo a lungo disattesi: non si poteva rischiare una
carestia, che avrebbe messo in ginocchio tutto il popolo, peggio ancora di
quanto saprebbe fare qualunque nemico...


Le alcove erano state troppo a lungo vuote, vuote
restavano le culle. Si preparavano pesanti anni futuri: perché mai volere
ancora di più inasprire la situazione? Troppo a lungo erano stati fermi i
commerci: alcuni prodotti ormai scarseggiavano o erano del tutto introvabili,
mentre di altri - che comunemente erano richiesti di là dal mare - enormi
scorte marcivano inutili.
Tutto ciò che alla fine si decise di fare fu di
mandare un ricco donario simbolico al tempio di Delfi, presso l’Oracolo Egeo.
Avrebbero preparato una grande statua bronzea del loro Dio Babi, con fattezze
che somigliassero a Lauchme, a testimonianza della riconoscenza perpetua dei
popoli della Terra del Sole - sia all’uomo e sacerdote loro padre, sia al Dio
loro Protettore. E così essi
sembravano cedere compiacenti al richiamo accorato del loro Sacerdote, mentre
in realtà gli negavano ogni ascolto.
Per la prima volta Norax assisteva, incredulo, ad
una sconfitta del suo Maestro. Per la prima volta, in verità, vi assisteva
Lauchme stesso, che non riuscì a rassegnarvisi, neanche dopo avere speso -
invano - tutte le sue molte e sagge parole su quella folla incredula, saccente
e pavida. Il suo solo commento fu:

“E’ veramente cominciato il tempo dell’uomo. E non mi piace”.

“E’ veramente cominciato il tempo dell’uomo. E non mi piace”.
Solo Iolao gli volle assicurare pubblicamente e
senza nessuna condizione l’appoggio della fiera gente di Kur, l’alta città dai
due porti, e della sua flotta.
Bakis ed i suoi più ardimentosi seguaci - i rudi
Iliesi - si dichiararono a favore di una pronta ed accanita difesa in caso di attacco
nemico, ma non vollero trasformarsi essi stessi in aggressori, per non recare
offesa e lutto e morte, a loro volta.
Questa presa di posizione sembrò la più sensata e quindi prevalse e dietro di essa
trovarono conforto gli indecisi e si nascosero i pavidi e gli ignavi, per cui
alla fine pesarono molto di più nel piatto della bilancia.
E questa fu la risoluzione del raduno, perché
Lauchme, anche sapendo di avere ragione, non avrebbe mai agito per dividere
gli animi. Troppi fantasmi del passato sarebbero rivissuti, ed egli ricordava
anche troppo bene di essere approdato sulla terra del sole, anni prima, proprio
dopo una lunga fuga da essi...
Una volta che tutti furono ripartiti, il gran
Sacerdote si richiuse in un ostinato mutismo e fu perfino schivo della
compagnia di chiunque, eccetto che di Lèkere, la sola che riusciva a dargli
conforto, e con cui molto si lamentò per la dolorosa perdita degli ultimi
eroi.


“Io ho la forza che mi vedono e per cui mi ammirano,
perché credo. Io credo che la mia
quotidiana e reverente vicinanza con i miei Dei mi permetta di averne
l’amicizia e la benevolenza. Non è
un’illusione, lo so da molte prove.
E ciò che più mi dà forza è il fatto che io so per
intero quale sia l’utilità del credere. Tanto che, se anche io, per ipotesi, non
credessi, sarei egualmente convinto
dell’assoluta necessità per tutti di radunarsi intorno ad un altare, per
riceverne conforto nella sventura, fiducia nell’incertezza, aiuto nella
necessità. E’ per questi motivi che io vesto i miei segni, per indicare chiaro
qual’è la mia missione, per far capire che l’assolverò compiutamente. Ma gli
uomini son deboli, e ricorrono alla forza della divinità solo nel mezzo del
temporale, pronti poi a negarla al primo schiarirsi del cielo. Essi corrono da
me, quando hanno bisogno; poi subito mi rinnegano e dubitano degli dei. Non immaginano
neanche a che dura prova essi mettano me, che devo rincuorarli nella loro
debole fede quando mi cercano e che devo sopportarne l’indifferenza, quando si
sentono più forti.


Eppure io credo: perché voglio, perché è necessario.
Perché devono esserci regole salde ed immutabili per sempre, a cui riferirsi. O
ci si perde. Ogni marinaio lo sa: e diventa per questo il sacerdote di sé
stesso, quando è in mare. Ma poi si perde come un bambino, nella vita di ogni
giorno, a terra. E’ per questo che anche se non ci fosse un solo Dio buono nel cielo, ma
soltanto demoni malvagi e perversi, io crederei egualmente e continuerei i miei
sacrifici, i riti sacri e le preghiere, e ancora vestirei così, come mi vesto
adesso. Per non perderci nel buio, per avere una vita migliore, perché l’uomo
non sia lupo all’uomo, perché l’uomo non sia schiavo dell’uomo, per trovare una
vera salvezza su una terra veramente libera”.


Questo discorso, come anche tanti altri simili,
Lekere ascoltò pazientemente, rendendogli ragione e confortandolo, ma inutilmente.
Norax intanto, che era intervenuto al raduno con la
sua compagna Larthy, sentiva di dovere ormai scegliere una dimora con lei, ma
nello stesso tempo molto temeva quel momento nel proprio cuore e tanto più lo
aveva temuto, quanto più lo aveva sentito avvicinarsi.
Un giorno le parlò, dolcemente, guardandola
teneramente negli occhi. E prima e dopo ogni parola la baciava sugli occhi, sul
viso, sulle labbra. Larthy sentiva l’agitazione del compagno, ma non ne
comprendeva la ragione.
“I miei occhi vedono te sola - egli le diceva,
quasi scusandosi - ed il resto sarebbe buio, se non l’illuminassi tu. I miei giorni
io li dividerò con te, se vuoi, fino alla fine. La stessa tavola e lo stesso
letto. Tu sarai per me quello che Lèkere é per il mio Maestro, oppure io non
sarò più nulla mai. Se non posso chiederti di recidere le tue nuove radici,
ovunque ti seguirò perché i tuoi affanni sono i miei, le tue gioie sono le
mie, i tuoi giorni sono i miei ed io altro non ho che te”.


Lacrime dolci scintillarono sulle mani carezzevoli
di Norax, mentre Larthy piegava il capo per baciarle...
Se questo soltanto era il motivo dell’affanno di
Norax, ebbene era una vana agitazione, che ella poteva subito dissipare...
Quando finalmente poté parlare, Larthy disse -
abbracciando Norax con insospettabile forza - nella sua voce gentile, ma ferma:
“Le mie nuove radici sei tu, ed io non ho e non avrò rimpianti. Il tuo posto é
il Grande Cerchio, lo so - perché l’eredità di grande sacerdote ti appartiene
negli intendimenti di Lygmon come nell’opinione della gente e nelle stesse tue
speranze - e quindi Tal-Ur é anche il mio
posto, dove io vivrò felice al tuo fianco, cote per la tua falce, purché tu sia pronto ad essere per me quello che
Lauchme é per Lèkere. Tu WA NA KA, Signore, figlio della Terra e del Cielo
stellato ed io PO TI NI JA, Signora delle fiere, padrona delle piante e di ogni
fecondità. Questo é il disegno degli dei, questo sarà, ogni giorno, per tutti i
nostri giorni, finché i prodigi divini porranno termine ai secoli terreni”.


E detto ciò, Larthy cominciò lentamente a recitare
sottovoce una nenia strana e carezzevole, che seppe accompagnare con abili
gesti suadenti delle mani, con significative espressioni del volto delicato e
con intensi sguardi degli occhi ipnotici: “Perché tu ed io - bambini
spaventati che si tengono per mano
per non perdersi a vicenda, soli, ma certo intenzionati ad arrivare in fondo a
quei sentieri sconosciuti - perché tu ed io ci siamo mai incontrati ed uniti?
Perché provi una vertigine reminiscente d’estate - ma più intima, più intensa -
in quei radi momenti in cui il sole ancor valido d’autunno sfilaccia un
nuvolone grigio, che copre ogni orizzonte, pigro e svogliato? Come le foglie
dell’ulivo, che poste sulla brace dormiente si saltano incontro e si accendono
- vive davvero nel loro breve attimo - e poi volano leggere, su, in cenere, per
consumarsi insieme nel vento: Così noi siamo, e percorriamo quei sentieri
scomodi come due bimbi non più troppo spaventati, perché si tengono per mano”.
Era un canto dolce e triste, intessuto della quieta
e non rassegnata disperazione di chi conosce i propri destini. Ma era anche la
promessa di fulgidi squarci inaspettati di libera, umana felicità.
Era la consapevole espressione della ferma volontà
di andare incontro al Fato Vorace, insieme e comunque, serenamente.


“La palla purpurea mi lancia Eros dai riccioli
d’oro, e con la fanciulla dai sandali variopinti mi invita a giocare. Godrò
appieno dei doni e del gioco, intenso nel tempo mortale, golosi i suoi faticosi
frutti, perché lungo riposo in premio mi attende”.
E gli occhi restarono fissi negli occhi umidi, furono
sorrisi i deboli sospiri, i corpi allacciati insieme, una sola anima, Larthy e
Norax, due piccole foglie d’ulivo sulla brace...
Poco alla volta, col tempo, Lauchme ritrovò
faticosamente la parola.
Ma se gli altri riscoprirono il piacere di ascoltarlo,
pure dovettero ammettere che i suoi discorsi avevano assunto una nota vagamente
triste e nostalgica. In realtà, chi gli era più vicino e meglio lo comprendeva
- come Lèkere e Norax - avvertiva che adesso più forte Lauchme sentiva l’antico
richiamo di Ereb.
Egli sentiva che la terra del sole lo aveva, in
qualche modo, respinto e tradito. Nel pavido e schivo atteggiamento dei suoi figli
egli vedeva, se non proprio un rifiuto della sua supremazia e della sua guida -
che essi mai avrebbero soltanto pensato di opporgli - almeno una prova di
insufficiente fiducia. Ed ecco che Ereb lo chiamava suadente, ed egli
ascoltava, adesso, nel silenzio ferito del
cuore, quel richiamo mai veramente sopito, che prima sempre aveva lasciato
cadere disatteso e che anzi lo aveva infastidito come un noioso ronzio di
mosche moleste.
Lo ascoltava, ma nel contempo vi resisteva, per non
tradire la paziente e preziosa opera di tutta una vita.
E questa lotta dei suoi sentimenti gli traspariva
sul volto scavato, nell’occhio più cupo e accigliato, persino negli adesso più
rari, ma ancora luminosi, sorrisi...
Erano stati completati i necessari nuovi sepolcri
per le sacre vittime della guerra. Il Grande Sacerdote aveva presieduto e supervisionato
i lavori, con cura, con amore. Aveva fatto costruire i due grandi tumuli a
forma di testa di toro - e purtroppo questi a malapena erano stati sufficienti
a contenere tutti i caduti dei valorosi guerrieri di Tal-Ur.
Ogni giorno, quindi, si era recato di fronte alle
grandi esedre poste nel semicerchio tra le ricurve corna del tumulo, a pensare,
a pregare, a sostenere l’amaro strazio delle vedove degli ultimi eroi...
Il rimorso gli si stringeva intorno al cuore come un crudele rovo spinoso.
_________
Un giorno - era ormai freddo, bianche le cime,
sopita la terra - Lauchme inaspettatamente espresse il desiderio di rivedere
Orwa, che già conosceva, e di visitare la nuova fortezza di Capo delle Acque,
che aveva giocato un ruolo così determinante nella vittoria. Dopo avere
comunicato questo suo desiderio a coloro che gli stavano più vicini, Lauchme
uscì dalla capanna e si diresse verso il tempio di Tal-Ur, per officiare un
rito breve, da solo.
Il Grande Nurake lo aspettava, gigantesco e paziente,
docile, come sempre...
Dopo avere salito i pochi gradini esterni, Lauchme
entrò lentamente, per abituarsi così più facilmente alla minore intensità di
luce. Percorse l’alto corridoio fino ad incrociare gli ingressi delle due
grandi Cambras laterali, ove venivano accolti ed istruiti al loro arrivo i
fedeli. Ora erano silenziose e vuote e riecheggiavano dei suoi passi nervosi,
restituendogli suoni di solitudine.


Qualche passo dopo, egli volse lo sguardo sulla
destra, verso il basso, sul fondo del Vanas, la cella in cui giaceva, sul proprio
fianco sinistro, il corpo di Hanys, mirabilmente incorrotto grazie alle
sapienti cure di Lauchme. Vicino al suo corpo erano il suo elmo, lo scudo,
l’antica e terribile spada, estremo dono, restituito, dopo l’ottima prova.
Poco discosto giaceva - in un sonno non più solitario
- il corpo di un altro eroe, dei tempi passati, anche questo adagiato sul
fianco sinistro, gli arti flessi, esposto all’adorazione eterna dei visitatori
di ogni tempo, dei pellegrini di ogni luogo.


“Avele Feluske, Hanys”, sussurrò, con parole che erano
carezze piene di rimpianto. Il sorriso di Lygmon era carico di amore e di
gratitudine insieme, per meglio poter superare, col proprio messaggio, il mare
sgomento che divide la vita luminosa dalla morte opaca.
Dopo aver silenziosamente comunicato, familiarmente,
con i due dormienti, Lauchme ne prese
delicato commiato e concesse solo uno sguardo disattento alla rampa spirale di
gradini, che portava ai piani superiori.
Là stavano la stanza dell’Oracolo, quella dei paramenti sacri, quella del vino preparato
per il sonno dei cinque giorni.
Lauchme procedette fino alla grande e maestosa Cambra
centrale, vi si inoltrò appena e quindi si fermò, ascoltando il lento respiro
del nuraghe, il proprio respiro. Era metà mattina, e la pallida luce del sole
obliquo giungeva testarda, ancorché debole, fino ad illuminare le tre grandi
nicchie sacre dell’alta sala circolare.
Parlò a lungo Lauchme - il padre della Vera Gente -
con la triade divina: il salutare dio Sole, l’Acqua sacra fecondatrice e la
fertile Dea Madre Terra.
Per ognuno accese una triplice lampada di olio di
lentisco, che bruciasse per tutto il tempo del colloquio. E parlò a lungo,
accorato e solo, con i suoi stanchi, poveri dei... Alla fine, da tanto parlare
scaturì di getto una domanda che da troppo lungo tempo scalpitava impaziente,
repressa nel petto del Sacerdote: “Dovrò io - Lauchme - umile servitore di Tal-Ur, portare il Galero
appuntito, il doppio mantello di lino, il Labrys e questo coltello sacro, solo
come simboli vani di un potere inutile, mentre una flotta armata soffocherà gli
ultimi rantoli vitali di questa bella terra? O non potrò, piuttosto - Lygmon
Twrsheno - ascoltare il dolce richiamo dei
fratelli Rasenna di là dal mare e con loro costruire, come so, le prime solide
basi per il più grande regno venturo del mondo?”.
Questa era la domanda, e fu con rabbia vera che il
sacerdote pronunciò per intero la propria indignazione ai suoi dei.
Le fiammelle trepide delle lampade sembravano
accompagnarlo, danzando consenzienti nel suo soliloquio: o almeno, in quello
che egli credeva essere tale.
Ma con sua sorpresa, l’oracolo era presente, invece, e gli rispose - con una strana voce tremante di emozione -
mentre il resinoso profumo del mirto andava pervadendo di sé le sacre stanze: “La tua decisione sarà comunque
degna di rispetto, e spetta soltanto a te, Lauchme. Non ne risponderai che a te
soltanto. Il futuro è tutto già impietosamente scritto nel libro del Fato. Non sarà certo cambiato a tuo
capriccio, per quanto tu soffra o ti ribelli. La tua voce, che noi valutiamo enormemente, come essa
merita, in realtà è meno di un ronzio di mosche, agli orecchi degli dei”.
Lauchme - riavutosi dalla sorpresa - cambiò tono,
ora che sapeva di non essere più solo:
“La scelta si pone tra l’essere facilmente accolto come utile amico in Ereb,
di là dal mare, da parte di chi di me ha in realtà poco bisogno - oppure essere inutile qui, male accetto
da parte di chi di tutto avrà bisogno, anche solo per sopravvivere, in questa Terra di Mucchi di Pietre”.
Gli rispose, sollecito, l’oracolo: “Sottintendi che,
invece, tutto il contrario dovrebbe essere, nella realtà delle cose. E forse
hai ragione. Ma non é come tu desideri. Per ragioni a te insondabili, che gli dei conoscono. Orgoglioso nella sconfitta, umile nella vittoria, sempre sei stato così,
Lygmon. La dignità del tuo agire e la sincerità della tua parola sapranno farsi
riconoscere preziose su qualunque sponda del vasto mare. La scelta, quindi, é
solo tua da prendere. Se tu vuoi, prendila adesso: il rammarico è l’unica preda
che resta alla freccia tardiva”.
E con uno strano singhiozzo l’oracolo tacque, non
visto - respirando piano, per non lasciarsi udire, le mani tremanti premute sui
begli occhi obliqui bagnati di pianto, piegato il corpo sulle ginocchia, la
fronte quasi a toccare il pavimento di pietra, unica ruvida certezza, ormai, in
una vita che sembrava perdere ogni appiglio certo e sicuro.
Negli ideogrammi di una lingua antica: WA NA KA,
“signore e padrone”, era scritto sulla soglia della capanna di Lauchme. PO TI
NI JA, “signora e padrona” era l’iscrizione sulla capanna di Lèkere. E quegli
attributi divini e quella sacra unione significavano molto di più di quanto
mirto, muschio o pietra, oppure onda del mare e vento potessero mai riuscire a misurare con le
proprie immense forze naturali soltanto, in tutta l’eternità del tempo...
Ma il rito era terminato, i lumi quasi del tutto
esauriti...
L’esitante fruscio della veste di Lauchme allora si
allontanò, leggero. Ma il suo cuore era pesante, tenacemente prigioniero,
preso tra le intricate e fitte radici ostinate del mirto profumato - o forse
ancora schiacciato e sepolto sotto quelle immani pietre muschiose - o forse, piuttosto,
già sperso tra i volubili flutti del mare, verso la lontana ed elusiva Ereb, nel vento?