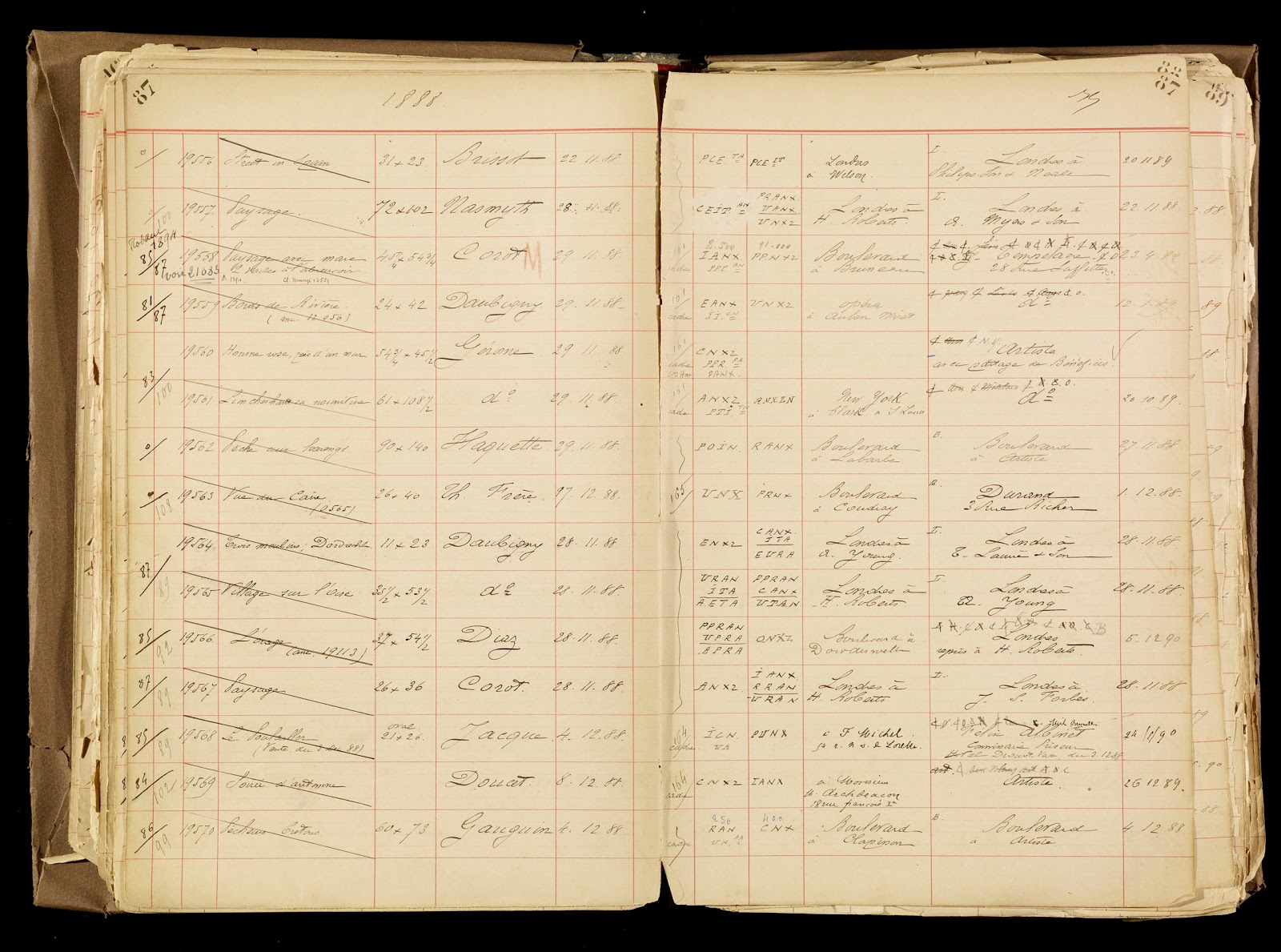Si tratta dell'unico cerchio ad avere un nome proprio
(escludendo il nono, che coincide con il lago ghiacciato Cocito).
Il nome Malebolge deriva dalla forma di tale cerchio, suddiviso in dieci bolge ovvero fossati
concentrici, cerchiati da mura e scavalcati da ponti di roccia, simili alle
fortificazioni esterne di un Castello. Dentro i fossati sono puniti i dannati,
suddivisi in base alla loro colpa.
Ecco la descrizione che il poeta ne dà, allorché vi giunge:
Ecco la descrizione che il poeta ne dà, allorché vi giunge:
«Luogo è in inferno detto Malebolge,
tutto di pietra di color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge.
Nel dritto mezzo del campo maligno
vaneggia un pozzo
assai largo e profondo,
di cui suo loco dicerò l'ordigno.
Quel cinghio che rimane adunque è tondo
tra 'l pozzo
e 'l piè de l'alta ripa dura,
e ha distinto in dieci valli il fondo.
Quale, dove per guardia de le mura
più e più fossi
cingon li castelli,
la parte dove son rende figura,
tale imagine quivi facean quelli;
e come a tai
fortezze da' lor sogli
a la ripa di fuor son ponticelli,
così da imo de la roccia scogli
movien che ricidien
li argini e ' fossi
infino al pozzo che i tronca e raccogli.»
|
“Ma non si può fare di tutte l’erbe un fascio” – qualche benpensante dirà.
Ebbene, sì, d'accordo: idee, fatti e persone vanno valutate bene e da vicino...
E poi: perché citare Dante?
E poi: perché citare Dante?
Ma perché l’intuizione di Dante resta ammirevole ed attuale: non v’è alcun dubbio che
la sua definizione dell’Italia (nel canto sesto del Purgatorio) sia tuttora – a distanza di otto secoli, purtroppo – la
migliore mai data.
- La popolazione italiana è infatti ancor oggi in molti modi schiava e vive in
un Paese che alberga moltissimo dolore e per il quale la similitudine con un
vascello privo di guida e preda di una grande tempesta è estremamente calzante.
Che poi l’Italia abbia la nobile pretesa di prendere il tè nei salotti buoni
d’Europa, ma sia in realtà più adatta ad un bordello, questa è la sferzante
critica del sommo poeta e politico, che dovrebbe offenderci e scatenare una reazione positiva…
Molti intellettuali sardi, poi, hanno reagito agli accenni (in
genere negativi) che Dante fa, nella Commedia, alla Sardegna ed ai Sardi. A tal riguardo, sono
stati scritti vari articoli, saggi e libri (che qui tralascio, per non troppo divagar, più del dovuto).
Nessuno, però, si è mai accorto di come “Malebolge” sia sempre più precisamente e sempre più spesso riferibile all’isola sarda...
La cronaca sarda recente avvalora sempre di più questa tesi...
Nessuno, però, si è mai accorto di come “Malebolge” sia sempre più precisamente e sempre più spesso riferibile all’isola sarda...
La cronaca sarda recente avvalora sempre di più questa tesi...
Reazioni.
A proposito di reazioni: il caso Csoa (Centro Sociale Occupato Autogestito) Pangea Porto Torres (csoa pangea.blog) rende purtroppo ragione all’antico detto che recita: “La strada per l’Inferno è spesso lastricata di buone intenzioni”.
Personalmente, non ne conoscevo neppure l'esistenza. Mi sono informato. Da solo, perché nessuno ha avuto la buona volontà di farlo. Si tratta di un gruppo spontaneo, nato per caso e per protesta (uno dei suoi motti è: "Occupare spazi per liberare menti"), animato - appunto - da buone intenzioni. Fanno raccolta di medicinali, ad esempio, e cercano di ideare molte altre buone iniziative, che siano anche altrettante critiche a rispettive manchevolezze da parte delle istituzioni. In genere, quindi: bene! Talvolta, però anche: male!
Personalmente, non ne conoscevo neppure l'esistenza. Mi sono informato. Da solo, perché nessuno ha avuto la buona volontà di farlo. Si tratta di un gruppo spontaneo, nato per caso e per protesta (uno dei suoi motti è: "Occupare spazi per liberare menti"), animato - appunto - da buone intenzioni. Fanno raccolta di medicinali, ad esempio, e cercano di ideare molte altre buone iniziative, che siano anche altrettante critiche a rispettive manchevolezze da parte delle istituzioni. In genere, quindi: bene! Talvolta, però anche: male!
Recentemente, Pangea ha proposto (in anticipo, su Facebook) ai propri sostenitori di entrare 'fuori orario' e scavalcando i cancelli nell'area archeologica di Monte d'Accoddi, per protestare contro la scarsa fruibilità del sito per un troppo breve orario d'apertura. L'iniziativa era criticabile per due motivi:1) i metodi proposti sono senza dubbio illegali e 2) i motivi stessi (gli orari troppo brevi d'apertura) non sussistevano. Cose che gli sono state fatte notare (http://www.sardiniapost.it/cronaca/archeologia-visita-clandestina-monte-daccoddi-larcheologo-sbagliato-e-pericoloso/).
I responsabili si sono scusati, hanno annullato il salto dei cancelli ed annunciato che avrebbero manifestato egualmente, ma comprato il biglietto (benissimo) e poi si sono scagliati 'testosteronicamente' a testa bassa contro alcuni di critici (tra cui - secondo loro - anche il sottoscritto che non li aveva mai sentiti nominare prima). In particolare, però, si sono scagliati contro l'Untore, (per chi non lo sapesse, si tratta di quel "Pasquino Sardo" che ama particolarmente fustigare tutti i meritevoli di biasimo, facendolo con modi degni di un tenutario di bordello d'angiporto).
E qui finisce il caso.
- Probabilmente Pangea - che ovviamente non intendeva ledere alcuno e certamente non ha rubato nulla - sarà molto più accorta in futuro e proseguirà con immutati ardore e senso di giustizia le proprie volonterose iniziative. Non ha la mia simpatia, ma ne farà benissimo a meno e tanti auguri lo stesso...
E qui finisce il caso.
- Probabilmente Pangea - che ovviamente non intendeva ledere alcuno e certamente non ha rubato nulla - sarà molto più accorta in futuro e proseguirà con immutati ardore e senso di giustizia le proprie volonterose iniziative. Non ha la mia simpatia, ma ne farà benissimo a meno e tanti auguri lo stesso...
- L'Untore, anche lui, continuerà la sua opera libellistica, ne sono certo...
- Malebolge Sardegna, però, prosegue anch'esso: attenzione! E molto più attivamente di quanto non si creda, anche...
Sarde Opere Pie.
Numerose altre iniziative 'benefiche' sono in corso: numerosi altri individui più o meno organizzati, soggetti singoli, organizzazioni, 'raccolgono fondi in vari modi per salvare i monumenti della Sardegna'...
Non si tratta di una nuova moda culturale: spesso, anzi, l'iniziativa parte proprio da persone che (si sarebbe propensi a credere) 'cultura' non sanno neppure come si scrive.
E - naturalmente - io non li conosco tutti: come potrei? Conosco solamente quelli che ogni tanto sono segnalati in Facebook o altrove sull'Internet. Non so neppure bene se si tratta di iniziative oneste, oppure no.
Non si tratta di una nuova moda culturale: spesso, anzi, l'iniziativa parte proprio da persone che (si sarebbe propensi a credere) 'cultura' non sanno neppure come si scrive.
E - naturalmente - io non li conosco tutti: come potrei? Conosco solamente quelli che ogni tanto sono segnalati in Facebook o altrove sull'Internet. Non so neppure bene se si tratta di iniziative oneste, oppure no.
Al loro confronto, però, quei numerosi 'autori autodidatti' che instancabilmente scrivono infinite fandonie fantasiosissime sulla Storia, l'Arte, l'Archeologia della Sardegna, sono solamente sublimi poeti astratti e disinteressati delle cose mondane, lontani dal mondo materiale, viventi nel loro empireo sognante. Che cosa vogliono, in fondo?
- Vogliono vendere i loro libri? Pinzellacchere: comperare è un gesto autonomo e libero. Se desidero acquistare un libro scritto su carta crespatina, è affar mio e mio diritto.
- Vogliono acquisire fama per scopi personali? Benissimo: bravi se ci riescono. In questo paese - è ben dimostrato dai fatti - qualsiasi 'Diroffarò' riesce a diventar famoso... Perché non proprio loro?
- Vogliono partecipare alle elezioni locali (non mi azzardo a credere nazionali!)? Facciano pure: il voto è libera espressione di libertà. E per quanto esso sia anche segreto, dico fin d'ora che io - almeno - non voterò per loro... Ma concorrano, perbacco!
Però...
Ma quando iniziano a chiedere soldi, amico mio, credo si debba pretendere di vederci chiaro... Se uno, per esempio, ti chiede soldi per sé, a titolo personale, è un conto.
Esempio:
"Dammi qualche cosa, sù!"
"Hai fame?"
"No"
"Hai una casa?"
"Sì"
"E allora a che cosa ti servono questi soldi?"
"Ho tanta voglia di comperarmi una auto nuova!"
Ecco: qui, l'interpellato almeno può scegliere - in omaggio alle libertà individuali - se mandare a quel paese il questuante (ipotesi statisticamente più probabile) oppure se agevolarne la raccolta di fondi per uso squisitamente personale (esercizio ad mentulam del libero arbitrio).
Ma - tra la folla fitta di onestissimi appassionati altruisti organizzati - esistono furbetti, furbacci e furbacchioni che raccolgono fondi 'per salvare beni pubblici' e poi magari li destinano ad altri. E un appassionato del monumento 'tal dei tali', magari, ci casca in perfetta buona fede (ingiusto dargli del coglione, come fa l'Untore: è un individuo cui viene sottratto il libero arbitrio a sua insaputa. Più brevemente: un truffato), convinto di donare per una buona causa pubblica e culturale e non invece per un'auto privata che presto prenderà a scorrazzare per tutta Malebolge, Sardegna.
Un'organizzazione che raccoglie fondi è Nurnet, una Fondazione che dispone sull'Internet di un sito estremamente accattivante e decorato di immagine fotografiche bellissime. Un'altra organizzazione è quella gestita e promossa da certa Albertina Piras ed altri (per es.: Maurizio Cossu), che credo vendano calendari con viste sarde. Certamente ne esistono altre...
Sarebbe certamente il caso che qualcuno si interessasse più da vicino e controllasse che le quote raccolte per un fine dichiarato, alla fine siano realmente indirizzate a quel fine e non altri. Interrogati direttamente al riguardo, i sunnominati dichiarano di 'non dovere rispondere a nessun altri che non abbia versato le quote'. (eppure la stampa e la vendita di calendari dovrebbe essere un'attività autorizzata e conseguentemente tassata). A tutt'oggi - purtroppo - non risulta che sia stata presa un'iniziativa di restauro verso alcun monumento pubblico (non ci sono neppure richieste di autorizzazioni a farlo, né sono stati fatti versamenti o donazioni ad alcun Ente).
Ultimamente, sembra che una Senatrice della Repubblica del M5S, Michela Serra, stia facendo proprio questa attività di raccolta d'informazioni (non diciamo indagine). Non credo che troverà molti libri contabili aggiornati, ma è già un inizio...
Altri - a Malebolge, Sardegna - sono estremamente scoperti, nella piena coscienza di non fare alcunché di male. Come un certo candido tenutario di Blog con poche pretese archeologiche, che - avendo anche una ben avviata rivendita di automobili - nello stesso spazio telematico alterna le notizie archeologiche di cui entra in possesso agli ultime prezzi delle sue auto revisionate (http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2015/01/offerte-commerciali-auto-della.html). Come dargli torto?
Egli è anche un noto ed attivo organizzatore di viaggi turistici conoscitivi in vari siti archeologici sardi, con incluso pranzo presso questo o quel ristorante situato convenientemente nei pressi (E qui ha risolto in modo molto brillante e personale l'adagio secondo cui con l'Archeolgia non si mangia: in realtà si mangia e talvolta anche di gusto). Unicuique suum...
Strabismo.
Ma purtroppo persiste un diffuso strabismo - sull'isola - che non permette sempre di guardare dritto alle cose e di metterne bene a fuoco il nocciolo del problema.
Un esempio:
- Un certo signor Armando Saba, sardo di Allai, è stato finalmente assolto - dopo un processo durato circa 8 anni - dall'accusa di essere un falsario. Siamo tutti contenti per lui.
(Per chi non conoscesse l'antefatto: esistono alcuni ciottoli di fiume, raccolti dal Lago Omodeo in secca, nella località 'Is Nabrones', con alcune incisioni che sembrano essere lettere della lingua etrusca. Il sig Saba riferisce che le trovò passeggiando e le affidò al locale museo di Allai. I reperti sono stati dichiarati 'falsi recenti' da due esperti: Mario Torelli ed Attilio Mastino).
Il giudice Antonio Enna non ha - alla fine - ritenuto in alcun modo dimostrato che il Saba fosse colpevole del falso: egli avrebbe solamente avuto la disavventura di rinvenire detti falsi e (non sapendoli valutare, ma ritenendoli autentici) di averli voluti affidare al luogo ove riteneva fosse gente più esperta di lui.
Saba è stato assolto e restituito alla serenità del suo piccolo e ridente paese.
Il problema - ora - è che tutti quei fantarcheologi che nel corso degli anni hanno 'tifato' per l'autenticità dei reperti di Allai interpretano l'assoluzione del Saba (nel corso di un processo che s'incentra proprio tutto sulla falsità dei reperti e sul riconoscimento oppure no della colpevolezza dell'imputato come autore del falso) come un'ammissione automatica di autenticità! Ciò può sembrare assolutamente incredibile, ma si legga pure al riguardo il Blog Monteprama (15 minuti dopo l'assunzione di una cpr. di antiemetico).
Quindi: Malebolge, Sardegna?
Sì: Malebolge, Sardegna...
Ma - tra la folla fitta di onestissimi appassionati altruisti organizzati - esistono furbetti, furbacci e furbacchioni che raccolgono fondi 'per salvare beni pubblici' e poi magari li destinano ad altri. E un appassionato del monumento 'tal dei tali', magari, ci casca in perfetta buona fede (ingiusto dargli del coglione, come fa l'Untore: è un individuo cui viene sottratto il libero arbitrio a sua insaputa. Più brevemente: un truffato), convinto di donare per una buona causa pubblica e culturale e non invece per un'auto privata che presto prenderà a scorrazzare per tutta Malebolge, Sardegna.
Un'organizzazione che raccoglie fondi è Nurnet, una Fondazione che dispone sull'Internet di un sito estremamente accattivante e decorato di immagine fotografiche bellissime. Un'altra organizzazione è quella gestita e promossa da certa Albertina Piras ed altri (per es.: Maurizio Cossu), che credo vendano calendari con viste sarde. Certamente ne esistono altre...
Sarebbe certamente il caso che qualcuno si interessasse più da vicino e controllasse che le quote raccolte per un fine dichiarato, alla fine siano realmente indirizzate a quel fine e non altri. Interrogati direttamente al riguardo, i sunnominati dichiarano di 'non dovere rispondere a nessun altri che non abbia versato le quote'. (eppure la stampa e la vendita di calendari dovrebbe essere un'attività autorizzata e conseguentemente tassata). A tutt'oggi - purtroppo - non risulta che sia stata presa un'iniziativa di restauro verso alcun monumento pubblico (non ci sono neppure richieste di autorizzazioni a farlo, né sono stati fatti versamenti o donazioni ad alcun Ente).
Ultimamente, sembra che una Senatrice della Repubblica del M5S, Michela Serra, stia facendo proprio questa attività di raccolta d'informazioni (non diciamo indagine). Non credo che troverà molti libri contabili aggiornati, ma è già un inizio...
Altri - a Malebolge, Sardegna - sono estremamente scoperti, nella piena coscienza di non fare alcunché di male. Come un certo candido tenutario di Blog con poche pretese archeologiche, che - avendo anche una ben avviata rivendita di automobili - nello stesso spazio telematico alterna le notizie archeologiche di cui entra in possesso agli ultime prezzi delle sue auto revisionate (http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2015/01/offerte-commerciali-auto-della.html). Come dargli torto?
Egli è anche un noto ed attivo organizzatore di viaggi turistici conoscitivi in vari siti archeologici sardi, con incluso pranzo presso questo o quel ristorante situato convenientemente nei pressi (E qui ha risolto in modo molto brillante e personale l'adagio secondo cui con l'Archeolgia non si mangia: in realtà si mangia e talvolta anche di gusto). Unicuique suum...
Strabismo.
Ma purtroppo persiste un diffuso strabismo - sull'isola - che non permette sempre di guardare dritto alle cose e di metterne bene a fuoco il nocciolo del problema.
Un esempio:
- Un certo signor Armando Saba, sardo di Allai, è stato finalmente assolto - dopo un processo durato circa 8 anni - dall'accusa di essere un falsario. Siamo tutti contenti per lui.
(Per chi non conoscesse l'antefatto: esistono alcuni ciottoli di fiume, raccolti dal Lago Omodeo in secca, nella località 'Is Nabrones', con alcune incisioni che sembrano essere lettere della lingua etrusca. Il sig Saba riferisce che le trovò passeggiando e le affidò al locale museo di Allai. I reperti sono stati dichiarati 'falsi recenti' da due esperti: Mario Torelli ed Attilio Mastino).
Il giudice Antonio Enna non ha - alla fine - ritenuto in alcun modo dimostrato che il Saba fosse colpevole del falso: egli avrebbe solamente avuto la disavventura di rinvenire detti falsi e (non sapendoli valutare, ma ritenendoli autentici) di averli voluti affidare al luogo ove riteneva fosse gente più esperta di lui.
Saba è stato assolto e restituito alla serenità del suo piccolo e ridente paese.
 |
| Palle di mare e palle di lago |
Il problema - ora - è che tutti quei fantarcheologi che nel corso degli anni hanno 'tifato' per l'autenticità dei reperti di Allai interpretano l'assoluzione del Saba (nel corso di un processo che s'incentra proprio tutto sulla falsità dei reperti e sul riconoscimento oppure no della colpevolezza dell'imputato come autore del falso) come un'ammissione automatica di autenticità! Ciò può sembrare assolutamente incredibile, ma si legga pure al riguardo il Blog Monteprama (15 minuti dopo l'assunzione di una cpr. di antiemetico).
Quindi: Malebolge, Sardegna?
Sì: Malebolge, Sardegna...