pubblico, senza commenti, da Sardinia Blog:
IL CASO. Scrittura nuragica e logopedia: tutto “sospeso” a Sassari
“Sospeso a data da destinarsi”: queste le parole dell’Università di Sassari in merito al ciclo di seminari “Il cervello che scrive: una visione interdisciplinare”, organizzati dalla facoltà di Medicina il 16, 20 e 30 ottobre, in cui si mescolava la logopediacon la presunta scrittura nuragica. Un binomio un po’ azzardato con basi scientifiche praticamente nulle ma che nei giorni scorsi deve aver creato più di qualche mal di pancia ai docenti dell’ateneo turritano sino ad arrivare alla decisione odierna, verosimilmente tra imbarazzi più o meno celati che fanno capire, tra le righe, che corsi simili non ne verranno più fatti. Impossibile, infatti, riuscire ad avere qualche commento in più sulla vicenda, tenendo conto che la facoltà di Medicina non è nuova a iniziative simili – il primo è datato al 2013 – che vedono coinvolti Maria Rita Piras, presidente del corso di laurea in Logopedia, Susanna Nuvoli, ricercatrice di Medicina Nucleare e Gigi Sanna, ex professore di latino e greco al liceo classico “De Castro”, attualmente docente di storia della chiesa antica all’Istituto di Scienze Religiose di Oristano, ma soprattutto autore di un tomo di ben 600 pagine pubblicato dalla casa editrice S’Alvure e dal titolo “Sardoa Grammata”, in cui ha cercato di dimostrare l’esistenza di una scrittura nuragica. Tesi rigettata da tutto il mondo archeologico e scientifico nazionale perché si basa su metodi che niente hanno a che fare con la ricostruzione storica di una lingua e basati su documenti di dubbia veridicità e provenienza.
Alla base del sodalizio tra i tre ci sarebbero gli studi della Piras sull’Alzheimer e in particolare su come i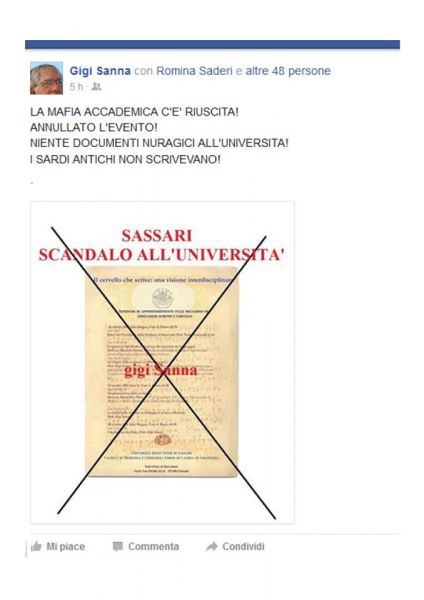 pazienti colpiti da questa malattia del cervello regrediscano mentalmente da un sistema grammaticale complesso ad uno più essenziale, in cui le lettere sono sostituite dai simboli. In sostanza il lavoro suggerirebbe la presenza nella mente umana di modelli universali linguistici, né più né meno come abbiamo nel nostro Dna geni riferibili ai nostri progenitori. Il tutto è finito in un libro “Archetipi e memorie del popolo sardo” edito da S’Alvure in cui il viaggio nella mente dei malati diventa anche un percorso lungo la storia umana e le scritture del passato. Sardo incluso.
pazienti colpiti da questa malattia del cervello regrediscano mentalmente da un sistema grammaticale complesso ad uno più essenziale, in cui le lettere sono sostituite dai simboli. In sostanza il lavoro suggerirebbe la presenza nella mente umana di modelli universali linguistici, né più né meno come abbiamo nel nostro Dna geni riferibili ai nostri progenitori. Il tutto è finito in un libro “Archetipi e memorie del popolo sardo” edito da S’Alvure in cui il viaggio nella mente dei malati diventa anche un percorso lungo la storia umana e le scritture del passato. Sardo incluso.
Lo studio di Sanna sulla presunta lingua nuragica si basa però sulle cosiddette tavolette di Tziricotu, quattro lastre in bronzo e gesso rinvenute in un luogo imprecisato di Cabras, che avrebbero avuto la funzione di una sorta di “stele di Rosetta” della lingua nuragica, dal quale ha tratto addirittura un alfabeto, sillabe, verbi. Ma questi reperti non solo non sono nuragici, ma si dubita anche della loro autenticità. Unico pezzo antico potrebbe essere quello in bronzo che, sulla base dei raffronti fatti, è stato datato dagli archeologi all’età bizantina e non sarebbe affatto un’iscrizione, ma bensì una placca per cinture. Mentre i presunti segni scrittori non sarebbero altro che le decorazioni il cui andamento speculare non si adatta alla successione tra possibili lettere e fonemi pronunciati.
A demolire ulteriormente la validità degli studi di Gigi Sanna poi, secondo i glottologi e i filologi, è il metodo linguistico storico che prevede una serie di situazioni non solo per la decifrazione di una scrittura, ma anche della sua esistenza; ovvero deve esserci una documentazione numericamente considerevole che permetta di poter raffrontare la continuità dei segni, in maniera tale da poter capire il suo sistema. Che poi si arrivi a capirlo in tempi brevi o meno è un altro discorso, basti pensare alla Lineare A, una delle scritture cretesi che, nonostante le tante tavolette, non è stata ancora decifrata. Fino ad ora gli esempi portati a sostegno del lavoro di Sanna sono una sessantina, tutti estremamente dubbi e numericamente poco rilevanti, soprattutto quando, con queste labilissime tracce, si ha la pretesa di parlare di sistemi di palazzo, scuole di scribi e un sistema economico e sociale che è ripreso dalla Mesopotamia del III millennio a. C. Se a questo aggiungiamo che Sanna nella comparazione linguistica mescola termini di chiara origine semitica al sardo attuale – che è una parlata neolatina, ovvero derivata dalla trasformazione dell’antica lingua degli antichi romani, al pari dello spagnolo, del francese e dell’italiano – si capisce come le pagine di “Sardoa grammata” siano tutt’altro che convincenti per chi è del mestiere.
Nonostante la sospensione, mal digerita da Gigi Sanna che in post su Facebook accusa “la mafia accademica” di aver annullato gli incontri, rimangono comunque delle domande per ora inevase che hanno necessità di essere chiarite il prima possibile: se proprio si voleva parlare di scritture nel mondo antico, non era il caso di chiamare chi questo lavoro lo fa sul serio, ne ha i titoli e la credibilità? Alla facoltà di Medicina i seminari di Sanna erano tutti a titolo gratuito? Lo sono stati anche in passato?
Alla base del sodalizio tra i tre ci sarebbero gli studi della Piras sull’Alzheimer e in particolare su come i
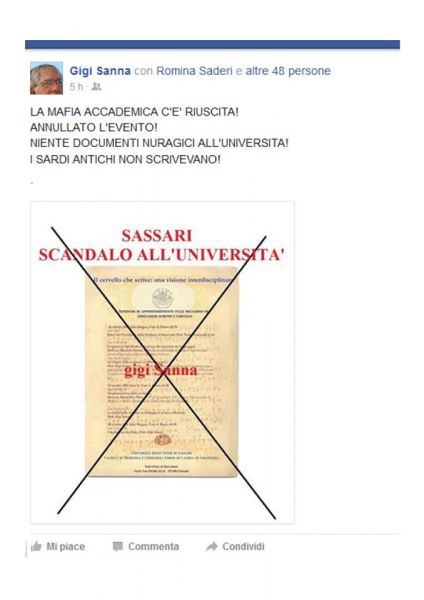 pazienti colpiti da questa malattia del cervello regrediscano mentalmente da un sistema grammaticale complesso ad uno più essenziale, in cui le lettere sono sostituite dai simboli. In sostanza il lavoro suggerirebbe la presenza nella mente umana di modelli universali linguistici, né più né meno come abbiamo nel nostro Dna geni riferibili ai nostri progenitori. Il tutto è finito in un libro “Archetipi e memorie del popolo sardo” edito da S’Alvure in cui il viaggio nella mente dei malati diventa anche un percorso lungo la storia umana e le scritture del passato. Sardo incluso.
pazienti colpiti da questa malattia del cervello regrediscano mentalmente da un sistema grammaticale complesso ad uno più essenziale, in cui le lettere sono sostituite dai simboli. In sostanza il lavoro suggerirebbe la presenza nella mente umana di modelli universali linguistici, né più né meno come abbiamo nel nostro Dna geni riferibili ai nostri progenitori. Il tutto è finito in un libro “Archetipi e memorie del popolo sardo” edito da S’Alvure in cui il viaggio nella mente dei malati diventa anche un percorso lungo la storia umana e le scritture del passato. Sardo incluso.Lo studio di Sanna sulla presunta lingua nuragica si basa però sulle cosiddette tavolette di Tziricotu, quattro lastre in bronzo e gesso rinvenute in un luogo imprecisato di Cabras, che avrebbero avuto la funzione di una sorta di “stele di Rosetta” della lingua nuragica, dal quale ha tratto addirittura un alfabeto, sillabe, verbi. Ma questi reperti non solo non sono nuragici, ma si dubita anche della loro autenticità. Unico pezzo antico potrebbe essere quello in bronzo che, sulla base dei raffronti fatti, è stato datato dagli archeologi all’età bizantina e non sarebbe affatto un’iscrizione, ma bensì una placca per cinture. Mentre i presunti segni scrittori non sarebbero altro che le decorazioni il cui andamento speculare non si adatta alla successione tra possibili lettere e fonemi pronunciati.
A demolire ulteriormente la validità degli studi di Gigi Sanna poi, secondo i glottologi e i filologi, è il metodo linguistico storico che prevede una serie di situazioni non solo per la decifrazione di una scrittura, ma anche della sua esistenza; ovvero deve esserci una documentazione numericamente considerevole che permetta di poter raffrontare la continuità dei segni, in maniera tale da poter capire il suo sistema. Che poi si arrivi a capirlo in tempi brevi o meno è un altro discorso, basti pensare alla Lineare A, una delle scritture cretesi che, nonostante le tante tavolette, non è stata ancora decifrata. Fino ad ora gli esempi portati a sostegno del lavoro di Sanna sono una sessantina, tutti estremamente dubbi e numericamente poco rilevanti, soprattutto quando, con queste labilissime tracce, si ha la pretesa di parlare di sistemi di palazzo, scuole di scribi e un sistema economico e sociale che è ripreso dalla Mesopotamia del III millennio a. C. Se a questo aggiungiamo che Sanna nella comparazione linguistica mescola termini di chiara origine semitica al sardo attuale – che è una parlata neolatina, ovvero derivata dalla trasformazione dell’antica lingua degli antichi romani, al pari dello spagnolo, del francese e dell’italiano – si capisce come le pagine di “Sardoa grammata” siano tutt’altro che convincenti per chi è del mestiere.
Nonostante la sospensione, mal digerita da Gigi Sanna che in post su Facebook accusa “la mafia accademica” di aver annullato gli incontri, rimangono comunque delle domande per ora inevase che hanno necessità di essere chiarite il prima possibile: se proprio si voleva parlare di scritture nel mondo antico, non era il caso di chiamare chi questo lavoro lo fa sul serio, ne ha i titoli e la credibilità? Alla facoltà di Medicina i seminari di Sanna erano tutti a titolo gratuito? Lo sono stati anche in passato?
Francesco Bellu
LEGGI ANCHE


