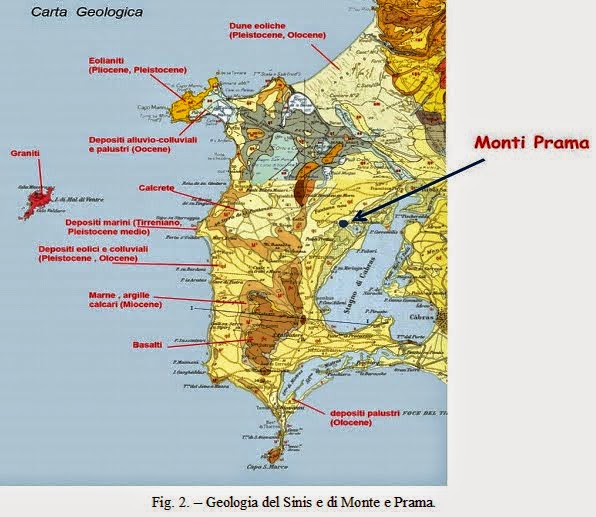Una curiosa serie di fatti e reperti simili.
 |
| Ricostruzione ipotetica |
Nell’ormai lontano 1934, un contadino abruzzese (Michele
Castagna il suo nome) stava impiantando una vigna, in un suo campo presso Ofena (antica Aufinum, 588 abitanti oggi)
in provincia dell’Aquila. Un masso gli fu d’ostacolo: andava rimosso.
Guardandolo meglio s’avvide che non era un semplice masso, bensì una parte di
una ‘statua a tutto tondo’ spezzata, della quale altri resti erano sparsi
intorno. Rinvenne pure un grosso ‘cappello’ (scolpito in una pietra differente,
ma facente parte della statua), sotto al quale si trovava un frammento di
un’altra e più piccola statua. Spostò il tutto di lato, perché la sua vigna era
più urgente ed importante.
Passò quasi un mese, prima che ci si accorgesse che quei
frammenti ‘potevano avere qualche importanza’.
Il motivo del nome.
La statua fu chiamata: “Guerriero di Capestrano”, dal nome di un paese allora molto più grande di
Ofena, oggi molto spopolato (da quasi 4.000 abitanti del 1921 si è passati ai
meno di 900 d’oggi) presso il quale fu rinvenuto. È scolpita in pietra calcarea
tenera locale. È una scultura funerea in pietra a tutto tondo. È datata secondo
quarto del VI secolo a.C.. è conservata al Museo Archeologico Nazionale di
Chieti. È considerata un capolavoro della scultura italica arcaica. La statua
femminile (mostra due piccoli seni stilizzati), più piccola ed incompleta fu
denominata “Dama di Capestrano”.
Sul sito un archeologo (Giuseppe Moretti) condusse uno scavo
entro l’anno (altre campagne di scavo furono solo sporadiche: 1973[1]
e 2003[2])
che mise in luce una necropoli comprendente 32/33 [quante sono le deposizioni di MontePrama?] tombe (21 ad inumazione, 5 ad
incinerazione e 6 sconvolte), orientate quasi tutte secondo un asse stradale,
per cui si sospettò la presenza di una ‘via Sacra’. Quindici di queste tombe
erano visibilmente più antiche, cinque di queste ultime erano orientate in modo
differente dalle altre…
Le tombe dal 12 al 15 erano disposte a raggiera intorno alla
numero 3, più grande ed accessoriata da una nicchia per il corredo funebre e
disposta in senso Nord-Sud. È sembrato lecito agli archeologi ipotizzare che –
secondo l’uso funerario ‘italico’ – la tomba fosse indicata da un circolo di
pietre e sormontata da un tumulo, sul quale torreggiassero due statue: quella
maschile più grande e quella femminile più piccola. In seguito furono persino
rinvenuti i due basamenti delle statue, che sfortunatamente sono andati poi
perduti.
Che cosa rappresenta.
Si tratta di un documento d’eccezionale rilevanza, che
rivela numerosi dettagli sull’armamentario bellico del Centro Italia dell’epoca
(tra il 700 ed il 600 a.C.), anche se lascia ancora molti dubbi circa i
relativi usi e costumi funebri.
Si tratta della statua di un uomo rivestito delle proprie
armi. È alta 2.09 metri, senza il plinto.
Il guerriero è rigidamente eretto, con i piedi distanti e
paralleli, sostenuto alle spalle da due appoggi di forma rozzamente piramidale,
che portano ciascuna incisa nella parte esterna la figura di una lancia (1.36 e 1.29 mt, lama ‘a foglia di
salice’ , innesto ‘a cannone’ e ‘amentum’ una correggia per prolungarne il
lancio). L’armatura è costituita da due dischi (Kardiophylax, di cui l’Archeologia ha fornito anche reperti
reali, che sono in lamina di metallo) uno sul petto e l’altro sul dorso,
sostenuti da corregge, una difesa triangolare (Mitra? che doveva essere in cuoio o in lamina metallica)
copre l’addome e l’inguine, rafforzata da una linea marginale più spessa
decorata a meandro.
 |
| Aspetto posteriore del Kardiophylax e della Mitra |
Le braccia sono strette sul davanti: sostengono una
spada con rilievi
d’animali fantastici sull’impugnatura, un pugnale senza elsa posto su questa ed un’esile
ascia incrociata
(che è stata interpretata come simbolo di rango o forse anche simbolo
identitario d’appartenenza, un po’ come il pugnale ad elsa gammata dei
bronzetti sardi; ma non se ne può escludere l’uso come arma vera); due
armille si stringono
intorno al braccio sinistro ed una intorno a quello destro; una doppia
collana con breve
ornamento sul davanti, cinge il collo (torquis).
Il viso si ritiene coperto da una maschera (metallica), la cui linea di
confine è nettamente segnata sul volto, e che, secondo la più comune
interpretazione, faceva parte dell’armatura; oppure sarebbe stata una maschera
funeraria che si
metteva addosso ai cadaveri, secondo un uso in voga fin dai tempi micenei e non
ignoto ai Romani. Per altri la linea scolpita ai lati del volto si riferirebbe
al soggolo dell’elmo.
 |
| Dettaglio della presunta maschera del Kardiophylax e dell'accetta simbolica |
Anche le orecchie sono forse rappresentate chiuse da una
difesa. Sulla testa, il guerriero ha un elmo a tesa larghissima (m 0,65 di
diametro) con un cimiero di penne (oggi in massima parte di restauro) fissato
ad un rialzo decorato a meandro.
La sproporzione evidente di questo copricapo ha fatto
pensare che si trattasse invece di uno scudo e tutta la statua rappresentasse
il defunto che assiste ritto (sostenuto dalle due lance) ai suoi funerali, con
lo scudo in testa, costume largamente praticato a Roma (Polyb., VI, 53)[3]
e presso i popoli italici. Lo scudo sulla testa andrebbe messo in relazione da
un lato con la devotio, per cui
ci si copriva la testa durante le funzioni religiose, e dall’altro con una
tendenza a dare a cippi tombali una copertura a forma di scudo (specialmente in
necropoli etrusche: Vetulonia).
Ipotesi suggestive.
L’ipotesi di riconoscere nel guerriero di Capestrano
un’immagine di consacrazione (devotio) sembra
confermata dall’altezza della scultura, corrispondente a sette piedi romani (Liv., VIII, 10, 12).[4]
[Si tratta di un rituale per il quale un comandante militare che
temesse la sconfitta, invocava terribilmente sopra di sé gli Dei Inferi, stando
sopra una lancia, e prometteva loro solennemente di portare con sé nell’Ade
schiere di nemici. Fatto ciò, si lanciava forsennatamente contro l’esercito nemico,
provocando sicuro scompiglio, perché i suoi avversari temevano di ucciderlo, in
quanto – divenuto egli ‘sacer’ – sul suo uccisore sarebbe caduta la maledizione
divina].
Malgrado l’indubbia suggestione di tale teoria, sembra proprio che la presenza di una statua femminile e i ritrovamenti in numerose località vicine di altre state sicuramente funerarie, gioca contro questa ipotesi.

Malgrado l’indubbia suggestione di tale teoria, sembra proprio che la presenza di una statua femminile e i ritrovamenti in numerose località vicine di altre state sicuramente funerarie, gioca contro questa ipotesi.

Le mani, posate in modo non naturale su addome e torace,
lasciano credere infatti ad una posa funeraria, di cui esistono esempi
mediorientali, relativi a personaggi di rango.
Lo sguardo ‘ieratico’ e sommario del volto delle statue
sarde di Monteprama potrebbe – secondo alcuni – avere il medesimo scopo:
illustrare la presenza di una maschera, seppure meno dettagliata di quella
di Capestrano. Forse,
esisterebbero anche altre similitudini cultuali.
Gli oggetti che si vedono raffigurati indosso al guerriero
sono stati identificati con altri rinvenuti in tombe etrusche o italiche delle
località relativamente vicine; il luogo infatti in cui era la statua era quello
di una popolazione che nelle proprie manifestazioni artistiche e culturali, pur
mantenendo una base di elementi indigeni (Piceni o Sabelli), riceveva influssi
Etruschi. I due dischi hanno riscontro con altri simili rinvenuti su scheletri
in tombe di Alfedena, elemento che poi si svilupperà con la corazza tipicamente
sannita formata da tre dischi sul petto e sulla schiena; il triangolo
sull’addome è simile ad altri di lamina bronzea scavati in Etruria e nel
Piceno; dell’ascia si ha un esemplare simile in ferro, trovato a Chiusi;
maschere sono state trovate a Chiusi e nel Piceno, in lamina bronzea; anche
elmi simili, però con tesa più ridotta, sono stati scavati nelle vicine regioni
adriatiche.
 |
| Veduta anteriore del torquis e del Kardiophylax |
 |
| Kardiophylax |
Reperto ancora discusso.
Sul problema artistico di questa statua si sono accese
notevoli discussioni; alcuni la vorrebbero ritenere un esemplare della metà del
VI sec., tipico della civiltà sabellico-picena, non estraneo quindi ad influssi
etruschi e anche greci, mediati o immediati, pur ostentando manifestazioni
primitive tipiche di ogni arte periferica; del resto, è facile il confronto
delle figure sull’impugnatura della spada con altre dell’arte etrusca
orientalizzante.
Un’altra corrente di studiosi, invece, mettendo questa
statua a confronto con monumenti dell’arte gallica e iberica, la valuterebbe
come concepita sotto un influsso predominante dell’arte celtica.
Su uno dei sostegni è incisa un’iscrizione in caratteri e
lingua presabellica o sud-picena, in cui probabilmente si deve leggere il nome,
patronimico, ecc., del defunto.
L’iscrizione.
È redatta in un alfabeto definito convenzionalmente
sud-piceno nell’arcaica lingua italica. Il testo consiste di una sola riga, dal
basso verso l’alto, lungo la faccia anteriore del piastrino di sinistra ed è
possibile leggerla quasi interamente, malgrado i danni e le interruzioni
determinati dalle fratture.
Si ritiene possibile che il committente (forse Aninis) fece fare (opsùt) la statua in
onore di Pomponio, in veste di suo erede (forse suo figlio) a capo della
comunità locale.
Si tratterebbe in definitiva di un’espressione artistica
interessantissima, forse legata al solido precedente protostorico della Daunia
del Nord (Puglia), recepito a sua volta dalla precedente tradizione statuaria monumentale orientale,
che giunse anche in Etruria nella prima età orientalizzante, senza attecchirvi in modo evidente.
La progressiva trasformazione delle prime statue-stele, aniconiche o con figura umana abbozzata, in vere e
proprie statue ha seguito un suo percorso ‘interno’ a questa regione, attestato da reperti quali
la stele di Guardiagrele, il torso di Atessa, la Testa di Numana.
 |
| Testa di Numana |
La statua funebre si fratturò in più punti per la fragilità
intrinseca del materiale, aumentata dalla realizzazione di punti sottili
(ginocchia e caviglie), in corrispondenza dei quali il cedimento non è stato
evitato dal rinforzo offerto dai due sostegni laterali.
Bibliografia.
G. Moretti, Il guerriero di C., con appendice epigrafico-linguistica di F. Ribezzo (Ist.
Naz. Arch. St. Arte - Opere d'arte, IV,
Roma 1936);
S. Ferri, Osservazioni intorno al guerriero di C., in Boll. d'Arte, 1949, pp. 1-9; M. Pallottino, Capestranezze, in Archeologia classica, I, 1949, pp. 208-210;
A. Boëthius, Sulle origini della scultura italo-etrusca, in Studî Etruschi, XXI, 1950, pp. 14-16; (cfr. anche A. Minto, I
clipei funerarî etruschi ed il problema delle origini dell'imago clipeata
funeraria, in Studî Etruschi, XXI, 1950, pp. 25-57;
F. Ribezzo, Popolo e lingua degli antichi piceni, ibidem;
E. Polomé, À propos du guerrier de C., in La nouv. Klio, IV, 1952, pp. 261-270;
L. Adams Holland, in Am. Journ. Arch., LX, 1956, p. 243 ss.;
A. Boëthius, in Eranos,
LIV, 1956, p. 202 ss.;
G. Radke, Pauly-Wissowa, VIII A, c. 1779 ss.
A. Chierici, Armi e società nel Piceno, con una premessa di metodo ed una nota sul
Guerriero di Capestrano, in Piceni e l’Italia medio-adriatica (Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi e Italici,
2000);
M. Ruggeri, Guerrieri e re dell’Abruzzo antico, Carsa Edizioni, Ascoli Piceno 2007;
M. Buonocore, L. Franchi Dell’Orto, A. La Regina, Pinna
Vestinorum e il popolo dei Vestini, I, “L’Erma” di Bretschneider, Roma 2011.
[1] Università
di Pisa e Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo.
[2] Vincenzo
d’Ercole, Soprint, Archeol. Abruzzo.
[3] Polibio racconta
di funerali romani di uomini illustri, nei quali si provvedeva ad
un’esposizione ‘eroica’ del defunto nelle sue armi, ritto in piedi. Riferisce
anche che fera uso comune conservare in casa immagini sacre (imagines
majorum) delle fattezze del defunto, da
esibirsi in occasione dei funerali solenni, montata su di un busto e rivestita
come se fosse una persona viva.
[4] Livio
racconta il rituale in relazione alla battaglia di Sentino (295 a.C., III
Guerra Sannitica o Guerra delle Nazioni) nel quale P. Decio Mure si immolò.
Riferisce anche che la Legge Sacra
prevedeva – nel caso in cui il comandante sopravvivesse – che si dovesse
seppellire una statua di sette piedi o più (2 metri e sette, coincidenti con la
statua del guerriero!) e che sul luogo nessun magistrato romano potesse
lecitamente recarsi.
[5] A. La Regina
interpreta come raki nevìi (per il Re
Nevio), mentre A. Calderini e S. Neri concordano per rakinelìs (un nome gentilizio, ancora non attestato).