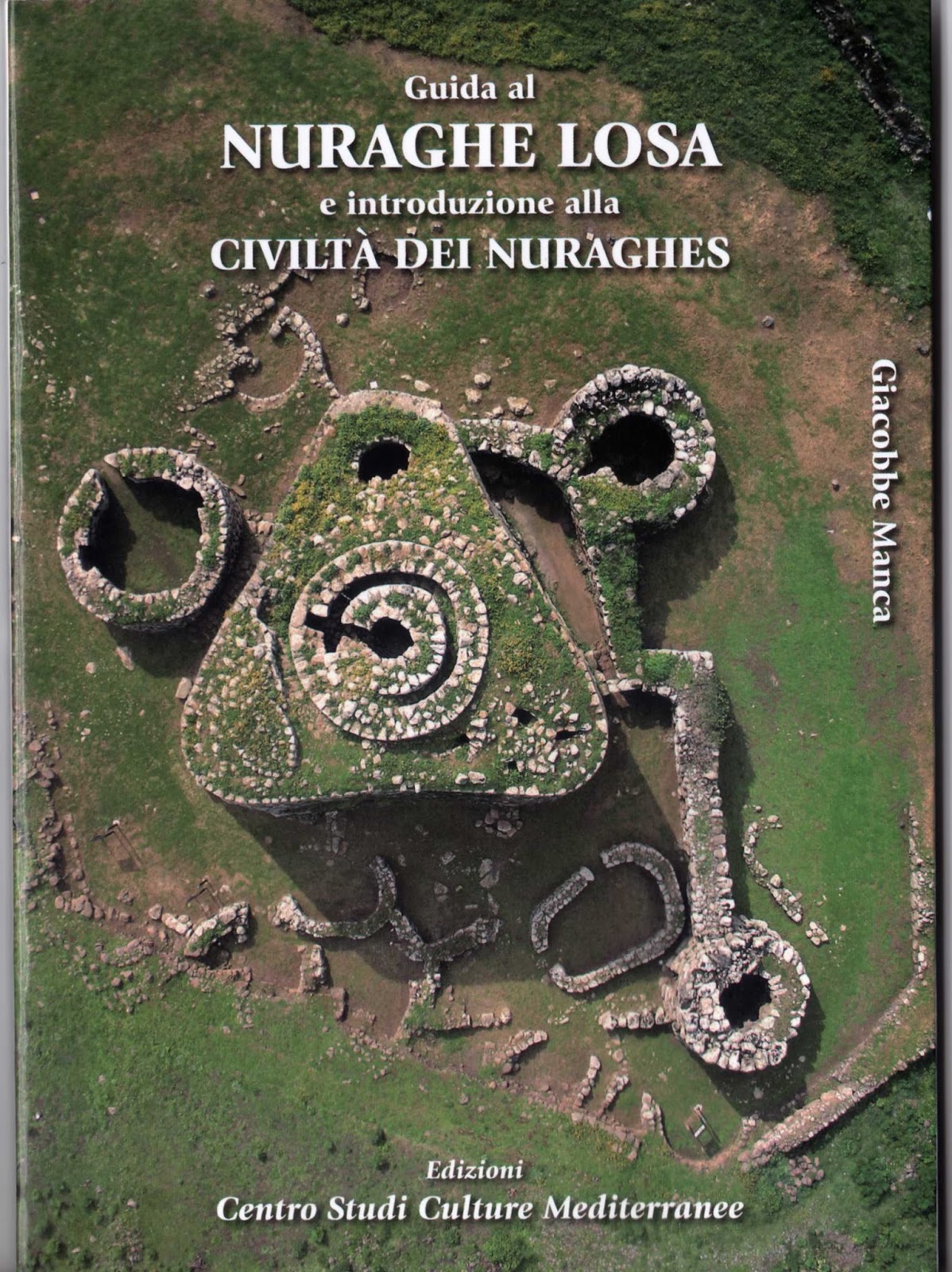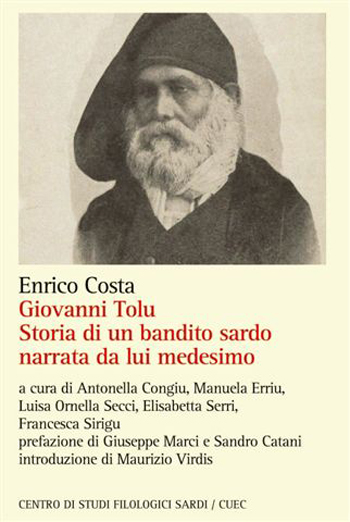“Sa Sedda ‘E Sos Carros
E La Valle Del Lanaitho”
Di M.A. Fadda e G. Salis
Serie ‘Guide ed Itinerari’ (46)
Carlo Delfino Editore
Non ci si aspetta certamente un trattato approfondito, bensì
un piacevole compagno di visita durante una scampagnata archeologica
naturalistica, come spesso la Delfino sa fare, con l’aggiunta d’iconografie in
genere sempre accattivanti.
In questo caso, però, sono rimasto deluso da troppi
dettagli, così tanti e vari, che non posso citarli tutti: mi limiterò a quelli che
considero più importanti per la comprensione dell’argomento, saltando a piè
pari gli errori di lingua italiana (‘silos’ al posto di ‘sili’, ‘cultuale e
non’ invece di ‘cultuale e no’, etc ) che, pur gravi, non compromettono
l’archeologia e la storia.
La prima parte del
trattatello è firmata da Gianfranca Salis, che tratta prevalentemente la parte
naturalistica ambientale e biologica. Qui, il difetto maggiore mi sembra stia
nel chiamare ‘Sisaia’ (scarafaggio, blatta) quella che in realtà
dovrebbe essere ‘Bisaia’ (bisavola). È
fatto senza neppure citare l’origine di questo spiacevole equivoco, nel quale
invece di una traduzione del termine scelto da ricercatori non sardi (Ferrarese
Ceruti e Germanà non conoscevano il sardo-nuorese), vi fu un irriverente tradimento
vero e proprio da parte d’accompagnatori e guide, che probabilmente consumarono
la loro marachella in un momento d’allegrezza alcolica.
La seconda parte è
prevalentemente la descrizione archeologica del sito e anche – più
malauguratamente – la sua interpretazione, a cura di Maria Ausilia Fadda.
Esistono numerosi motivi di disappunto, qui.
- Per primo: il riferimento al nome del sito “Sedda ‘E Sos
Carros” è attribuito a un’antica economia legata alla selvicoltura (che è falso; l’economia era pastorale: il taglio
degli alberi fu un ordine preciso impartito dal re piemontese, accompagnato da
false promesse che non furono mai esaudite e che alla fine danneggiarono
gravemente l’economia e l’ambiente locali).
Già l’introduzione d’ambientamento è molto fuori bersaglio, quindi…
Il sito risale al 1300 a.C. La Fadda non dice che il sito è bellissimo. Né che si tratta di
un’opera di inaspettata e brillante ingegneria idraulica non
necessaria, tanto ben studiata ed
interamente artistica quanto certamente del tutto superflua per la
sopravvivenza quotidiana della comunità locale.
L’archeologa deduce che il luogo fosse un tempio ad una divinità
dell’acqua*, che illustra le capacità
progettuali degli architetti nuragici* tra il 1200 ed il 700 a.C.
Se gli archeologi sardi imparassero una buona volta a
scrivere comunicando l’entusiasmo (che
essi stessi dovrebbero provare, prima, durante e dopo gli scavi) per ciò che è
bello e vale ed è significativo, forse anche i lettori s’appassionerebbero e
sarebbero più numerosi. Invece essi scrivono come se fossero tecnici annoiati
di sala settoria che esaminano un cadavere già freddo, procedendo ad elencare
lettere e numeri di ambienti e suppellettili, senza gioia, senza un lampo di
luce, senza il sorriso da bambino che la sorpesa sa sempre accendere sul viso
di chiunque veda certe cose per la prima volta. Invece l’autrice si sofferma niente, troppo poco sull’eccezionalità del sito, per lanciarsi subito sulla descrizione di come e perché presto (troppo presto) questa meravigliosa struttura sia stata distrutta dalla natura… L'impressione che il lettore ne ricava è quella di un effimero di vita breve.
*Faccio notare di passaggio che non ci vuole troppa fantasia
a pensare ad un’ignota divinità dell’acqua, ma che altre ipotesi sono
possibili. Più grave è invece il riferimento (ripetuto) agli ‘architetti
nuragici’ nell’epoca cui le date si
riferiscono.
Il ‘Nuragico’ era ormai finito. I Sardi che edificarono i
Bagni di Sedda ‘E Sos Carros erano certamente i legittimi eredi lontani dei
Costruttori, ma appartenevano ad un’altra Cultura e non costruivano più da
secoli i Nuraghi (e la Fadda stessa lo dice: "i cui valori alla fine del bronzo furono messi in crisi dall'apporto fondamentale di culture esterne che si andavano affermando in tutto il Mediterraneo").
Ne riproducevano le icone – certamente – come sarebbe
possibile comportarsi in altro modo, in un’isola che ti presenta un nuraghe
quasi ovunque tu ti possa voltare? Ma definirli ‘nuragici’ equivale a
legittimare la medesima definizione per chiunque, ancora oggi, porti una
maglietta con un nuraghe sopra: non è scientifico e confonde il lettore.
Peggio ancora con le ipotesi formulate. Ne cito tre
solamente.
- A me importa poco immaginare il vero motivo per cui si
saldassero alla pietra sottili bronzi a forma di spade, preparati in precedenza
dai fanatici (addetti al fanum/tempio)
per i fedeli che pagavano certamente un obolo. Mi pare evidente che l’obiettivo
fosse l’obolo, per il mantenimento del tempio e che i fedeli l’avrebbero
versato per qualunque altra forma in bronzo fuso gli potesse essere proposta. I
tripli salti mortali per dimostrare comee perché si legasse simbolicamente la
riproduzione votiva di una spada alla possibile divinità ctonia dell’acqua sono
– conseguentemente, per me – buffissimi.
- L’archeologa cita altri siti simili a questo (innecessariamente,
secondo me: non è una pubblicazione scientifica, si tratta di divulgazione!) e
fa riferimento al ‘battesimo del sangue’ immaginato da altri colleghi per gli
altri siti. Alla fine dell’inutile divagazione, ella esclude che il sangue
animale fosse mai stato usato nel fine meccanismo di scorrimento vascolare di
Sedda ‘E sos Carros, perché si sarebbe ostruito… A parte il fatto che non vedo affatto la necessità d’immaginare
(senza un valido motivo d’appoggio) riti così cruenti per i Sardi di qualunque
epoca, vorrei tranquillizzare la signora Fadda circa il fatto che il sangue non
avrebbe ostruito un bel niente e sono disposto a tenerle una lezione privata
gratuita circa il fenomeno fisiologico della coagulazione dello stesso, purché
mi prometta di non scrivere più simili corbellerie ...
- Infine, l’archeologa trova il modo di stupirsi (non di
fronte alla meraviglia struttura) per via della presenza di ‘abbondanti
frutti di mare, come telline, patelle ed altre conchiglie, che dimostrano che i
nuragici del Lanaitho avevano trovato un rapido sistema di collegamento per
raggiungere la costa in tempi brevi e fare ritorno alla valle in tempi brevi
per consumare cibi facilmente deperibili’.
Qui siamo, più propriamente, nel mondo di Voyager: il
reperimento di gusci di conchiglie in un sito abbastanza lontano dal mare non
ci fa pensare alla possibile raccolta per braccialetti, collane ed altri
ornamenti, bensì – subito – al consumo alimentare, sottointeso come abituale e
giornaliero.
Ammetto sia possibile un uso alimentare.
Ma non posso fare a meno di sottolineare che diversi
articoli scientifici hanno dimostrato senza ombra di dubbio che in Sardegna (ma
in tutto il Mediterraneo antico) non si consumavano di regola mai (se non proprio eccezionalmente) prodotti di
mare. Un articolo riassuntivo/esplicativo di ciò è comparso recentemente
sull’ultimo numero della rivista semestrale “Sardegna Antica”, numero 45:
“Paleo dieta dei Sardi Preistorici”.
Splendida l’iconografia.
Insoddisfacente il testo.
Splendido il posto.
Merita il viaggio, un po’ scomodo e lungo, a fronte dei
numerosi motivi per affrontare
l’escursione: naturalistici e paesaggistici, archeologici, fotografici e altro
ancora (se incontrate un muflone, capirete esattamente cosa altro!). Un'altra Sardegna, che resiste per quanto possibile alle antiche mortificazioni e cerca di non subirne più.







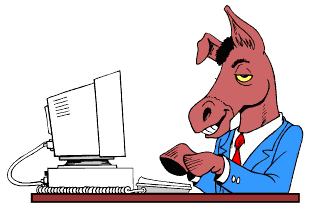
.jpg)