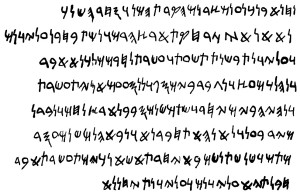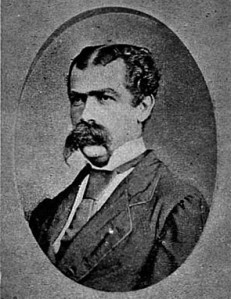PROPOSTA DI REVISIONE PARITARIA (peer review).
Caro Pasuco:
Come tu ben sai, ho riportato su questo blog numerosi articoli sui falsi
ideologici, storici, archeologici ed epigrafici.
Ho inoltre – chi ha letto lo sa bene, Pasuco – anche quello che è
l’identikit del falsario, ovunque nel mondo e quali siano i moventi che lo
spingono ad affermare, scrivere e divulgare pensieri ed opere distorte e
fuorvianti.
Mi sono astenuto dal riportare qui i nomi dei falsari, che pure si conoscono, esclusi
coloro che appartengono al passato ormai trascorso.
Mi rendo inoltre conto – come mi ha ammonito un caro amico
più colto ed esperto di me – del fatto che la mia lotta sia molto simile alla
donchisciottesca caccia ai mulini a vento. I falsari – lo affermano gli stessi
studiosi che li combattono – non saranno mai eliminati dalla faccia della terra:
ogni giorno nascono burle di vario livello, favole metropolitane buffe e
divertenti, truffe ingegnose volte all’affermazione di sé oppure al guadagno ed inverecondi inganni per motivi ideologici, politici o altro...
Ho portato anche alcuni esempi famosi ed evidenti, utili a
dimostrare che i falsi danneggiano tutta l’Umanità, in quanto tutti, chi più chi meno, rallentano il progredire della Cultura e sviano l’attenzione del grosso
pubblico e talvolta anche degli specialisti dalla Verità.
Io sono fermamente convinto che esista un sistema per
sbugiardare i più ostinati tra coloro che seguono – ed indicano ad altri –
questa miserabile strada sbagliata, pretendendo inoltre di conservare il
rispetto e persino di guadagnare la fama.
E’ il sistema della “Revisione Paritaria” (meglio nota
nell’espressione inglese “Peer Review”).
Gli editori e le agenzie di finanziamento usano proprio la
tecnica di valutazione tra pari per
selezionare le proposte ricevute. Questo processo costringe gli autori ad
adeguarsi ai migliori standard di qualità della loro disciplina,
oppure ai requisiti specifici della rivista, o dell'agenzia finanziatrice.
Pubblicazioni e progetti di ricerca che non siano stati soggetti a una
revisione dei pari non sono generalmente considerati scientificamente validi
dai ricercatori e dai professionisti del settore, se non dopo eventuali e
accurate verifiche. La valutazione tra pari è nata assieme alla crescita e
standardizzazione editoriale dei periodici scientifici, non è priva di difetti
e di proposte di perfezionamento, ma nei fatti questo sistema è quello che ha
maggiormente contribuito allo sviluppo della conoscenza scientifica, verificata
attraverso un metodo scientifico, nella società moderna con l'affermarsi di un
consenso nel tempo intorno alle varie tematiche di pari passo con le rispettive
verifiche sperimentali.
COME FUNZIONA.
La revisione paritaria sottopone il
lavoro o le idee di un autore allo scrutinio di uno o più esperti del medesimo
settore. Ognuno di questi esperti fornisce una propria valutazione (solitamente
valutazioni di metodo e/o ricerca di prove valide), includendo anche
suggerimenti per l'eventuale miglioramento, ad un redattore o ad un altro
intermediario (tipicamente, la maggior parte delle valutazioni sono comunicate
anche all'autore stesso).
Le valutazioni solitamente includono
raccomandazioni esplicite su cosa fare del manoscritto o della proposta, spesso
scelte tra opzioni proposte dal giornale o dall'editore. La maggior parte di
tali raccomandazioni rientra tra le seguenti:
- il lavoro è accettato senza riserve;
- il lavoro è accettato, a patto che l'autore lo
migliori sotto determinati aspetti;
- il lavoro è respinto, ma se ne incoraggia una
revisione e una riproposta;
- il lavoro è respinto senza appello.
In questo processo il parere degli
esperti di fatto è solo consultivo e l'editore non assume alcun obbligo formale
ad accettarne le conclusioni.
Inoltre, nelle pubblicazioni
scientifiche, gli esperti non lavorano in gruppo, non comunicano tra loro e
normalmente non sono a conoscenza delle identità degli altri esperti.
Normalmente non vi è necessità che gli esperti esprimano un giudizio
consensuale, a differenza d’altri ambiti, quale per esempio la giuria di
tribunale.
Nel caso i pareri degli esperti divergano tra loro in maniera consistente
sulla qualità di un lavoro analizzato, vi sono diverse strategie per dirimere
la questione.In alcune discipline, esistono luoghi arbitrati quali conferenze e laboratori. Per essere ammessi a parlare, gli scienziati devono sottoporre in anticipo un lavoro scientifico (in genere breve, 15 pagine o meno). Questo documento viene revisionato da un "comitato di programma" (l'equivalente di un consiglio editoriale), che in genere richiede opinioni dai revisori. Le scadenze rigide imposte dalle conferenze tendono a limitare le opzioni per l'accettazione o il rifiuto del documento.
Le riviste scientifiche osservano universalmente questa convenzione. I due o tre revisori selezionati riportano al redattore la loro valutazione dell'articolo, assieme a dei suggerimenti per migliorarlo. Il redattore riporta quindi l'insieme dei commenti all'autore (alcuni commenti possono essere stati segnalati al redattore come confidenziali), nel frattempo basandosi su essi, decide se pubblicare o meno il manoscritto. Quando un redattore riceve commenti molto positivi e molto negativi sullo stesso manoscritto, spesso sollecita una o più revisioni aggiuntive per spezzare l'incertezza.
Un'altra strategia in mancanza di un chiaro consenso è quella di invitare l'autore a replicare alle critiche dei revisori e permettere una confutazione convincente, per sciogliere l'incertezza. Se un redattore non si sente sicuro nel valutare la persuasività di una confutazione, può sollecitare una risposta al giudice che portò la critica originale. In rari casi, un redattore trasmetterà le comunicazioni tra autore e revisori, permettendo in pratica di discutere un punto. Anche in questi casi, comunque, i redattori non permettono ai revisori di conferire tra loro, e lo scopo esplicito del processo non è quello di raggiungere il consenso o convincere qualcuno a cambiare la propria opinione. Alcune riviste mediche comunque, (di solito seguendo il modello dell'accesso aperto) hanno pubblicato su Internet la storia precedente alla pubblicazione di ogni articolo, dalla candidatura originale ai rapporti dei revisori, ai commenti degli autori, ai manoscritti revisionati.
Dopo aver rivisto e risolto qualsiasi potenziale nodo, ci sono tre esiti possibili per l'articolo.
I due più semplici sono lo scarto diretto e l'accettazione incondizionata. In molti casi agli autori è data una possibilità di rivedere il lavoro, con o senza raccomandazioni o richieste specifiche da parte dei revisori.
Ecco dunque la mia proposta:
1)
Basterebbe che i tanti e numerosi tromboni che propalano
pappecotte non scientifiche e totalmente false fossero costretti ad una peer
review (anche se – certamente – la revisione non sarebbe fatta da persono pari
a loro, bensì studiosi seri).
2)
Alcuni di essi hanno in realtà già provato a proporre al mondo
scientifico i loro ‘lavori’ che – naturalmente – sono stati respinti. Sarebbe doveroso rendere pubbliche queste
sonore bocciature, in modo che si possa sapere bene da che pulpito giungano
certe prediche: credo che molte sale e molte piazze resterebbero deserte...